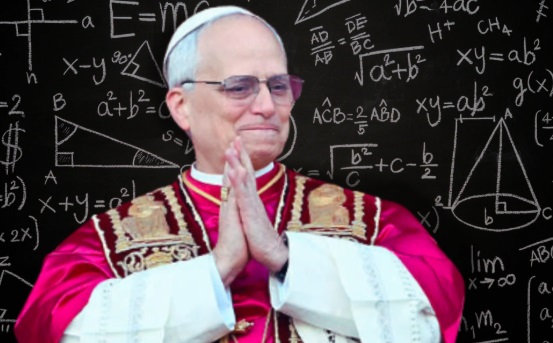Cultura
Il sacro, spazio di condivisione tra tante religioni e culture

La retrospettiva presenta il Mediterraneo come spazio di incontro tra civiltà che condividono archetipi religiosi
Tra gli eventi culturali previsti nel programma del Giubileo della Speranza c’è l’esposizione dal titolo “Luoghi sacri condivisi. Viaggio tra le religioni”, inaugurata il 09 ottobre presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, e visitabile fino al 19 gennaio. Curata da Dionigi Albera, direttore di ricerca presso il Centre national de la recherche scientifique (CNRS), insieme a Raphaël Bories e Manoël Pénicaud, la mostra è stata realizzata con il sostegno del Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) di Marsiglia e della stessa Accademia francese presso la Santa Sede, e beneficia del sostegno di BNL BNP Paribas. Un viaggio sensazionale nell’universo del sacro è ciò che attende coloro i quali si accingono a visitare la rassegna, che consta di circa 100 opere provenienti dai Musei Vaticani, dal Museo Ebraico di Roma, dal Louvre e dal Mucem, realizzate da vari artisti fra cui Gentile da Fabriano, Chagall e Le Corbusier. Il concetto che si vuole comunicare è che il sacro non è qualcosa di chiuso e confinato in un unico luogo, ma è qualcosa che accomuna e mette in relazione più realtà e più popoli. Si creano quindi situazioni di condivisione, di interscambio, di dialogo, di tolleranza e di interazione tra civiltà diverse. “Si vuole mettere l’accento sulla dimensione della comunanza piuttosto che su quella della divisione”, le parole di Albera. Tanti manufatti ed episodi si caratterizzano per il fatto di essere trasversali a più confessioni sparse per il Mediterraneo, il Mare Nostrum che unisce e valorizza le alterità. La mostra è divisa in sette sezioni: “Città sante”, “Il mare”, “Il Giardino”, “La montagna”, “La grotta”, “Oggetti erranti” e “Architetture”. Sono “archetipi” comuni a tante culture religiose recanti, nella maggior parte dei casi, significati multipli. Il mare, per esempio, è rapportato al pericolo e alla necessità di richiedere un aiuto salvifico a Dio. Il tema del salvataggio miracoloso è trattato nella tavola in tempera e oro “Scomparto di predella con Storie di San Nicola: il Santo salva una nave dal naufragio” del 1425, conservata nei Musei Papali e ora esposta in questa mostra. Il pittore Gentile da Fabriano rappresenta san Nicola che, secondo la leggenda, calma la tempesta proteggendo i naufraghi. È considerato un santo sauroctono capace di sconfiggere il male sotto forma di un drago, come San Silvestro. Il quadro, che funge un po’ da filo rosso di tutta la retrospettiva, è Ur Salim (Città della Pace) realizzato nel 2022 dal palestinese Rayan Yasmineh, ora conservato nella Collezione Dollo-Paulin a Parigi. Il pittore ripropone il tema del giardino che richiama l’Eden per i cristiani, ma anche un luogo di calma e di pace per i musulmani. Sullo sfondo spiccano il paesaggio della Gerusalemme terrestre che rievoca quella celeste, insieme agli alberi di arancio e di quercia e ad altri fiori e frutti dai colori lussureggianti, ispirati agli arazzi medievali e alle miniature persiane. Yasmineh combina sapientemente mitologia e iconografia mediorientali con le identità occidentali contemporanee, ritenendosi un artista dall’identità plurima: cristiano da parte paterna e musulmano sciita da parte materna. Non mancano i cosiddetti “oggetti erranti” che, nel corso della loro vita, sono stati trasportati in luoghi diversi arricchendosi di nuovi significati. Basti pensare alla “Bibbia di San Luigi” o “Bibbia ricca”, un manoscritto medievale del XIII secolo in tre volumi, contenente ben 4898 miniature che illustrano scene dell’Antico e del Nuovo Testamento. Realizzata in Francia per Luigi IX su richiesta di sua madre Bianca di Castiglia, questa Bibbia illustrata fu inizialmente pensata per non avere delle sezioni scritte. Subì, tuttavia, delle modifiche con l’aggiunta di testi inseriti in Italia nel XIV secolo, seguiti da commenti su contenuti arabi in lingua farsi, quando venne data in dono allo scià di Persia, e da annotazioni giudeo-persiane elaborate da un mercante ebreo nel Settecento. Il volume, partendo da una radice comune che è la Bibbia, riconosciuta dalle tre religioni monoteiste, si è contaminata nel tempo con più contributi culturali diventando testimone di una comunicazione transfrontaliera. Un discorso interessante investe anche il settore architettonico. Tanti sono gli edifici religiosi, frutto di ibridazione tra gli elementi strutturali portati da una cultura religiosa e gli elementi di un’altra. Una chiesa diventata moschea o viceversa preserva tracce sia dell’architettura cattolica che di quella musulmana. La Grande Moschea degli Omayaddi a Damasco, per esempio, è nata come chiesa costruita sulle rovine di un tempio politeista, poi divenuta moschea. Costruita in onore a san Giovanni Battista, la moschea ha manutenuto una reliquia del santo a dimostrazione del fatto che è un personaggio biblico che parla a tutti, perfino agli arabi che ne preservano la memoria. Nel nostro contesto italiano ricordiamo, invece, il Santuario della Madonna di Porto Salvo a Lampedusa, eretto nel 1745, diventato un sito venerato sia dai cristiani che dai musulmani. Lampedusa è infatti luogo di incontro e di condivisione pacifico tra più popolazioni. In linea con la logica di riunire e avvicinare fra loro più siti e religioni, è in corso il progetto della costruzione della casa di preghiera e di insegnamento “House of One” nel centro di Berlino, un edificio interreligioso che intende accostare una sinagoga ad una chiesa e ad una moschea, allo scopo di stabilire una coesistenza pacifica tra ebraismo, cristianesimo e islam. La mostra, che dalla Francia sta girovagando per l’Europa e approderà in Oriente, è visitabile anche tramite il catalogo co-edito da Silvana Editoriale e da Villa Medici, che contiene approfondimenti curati da altri esperti.