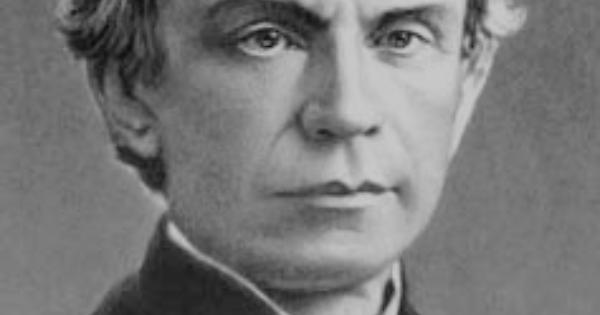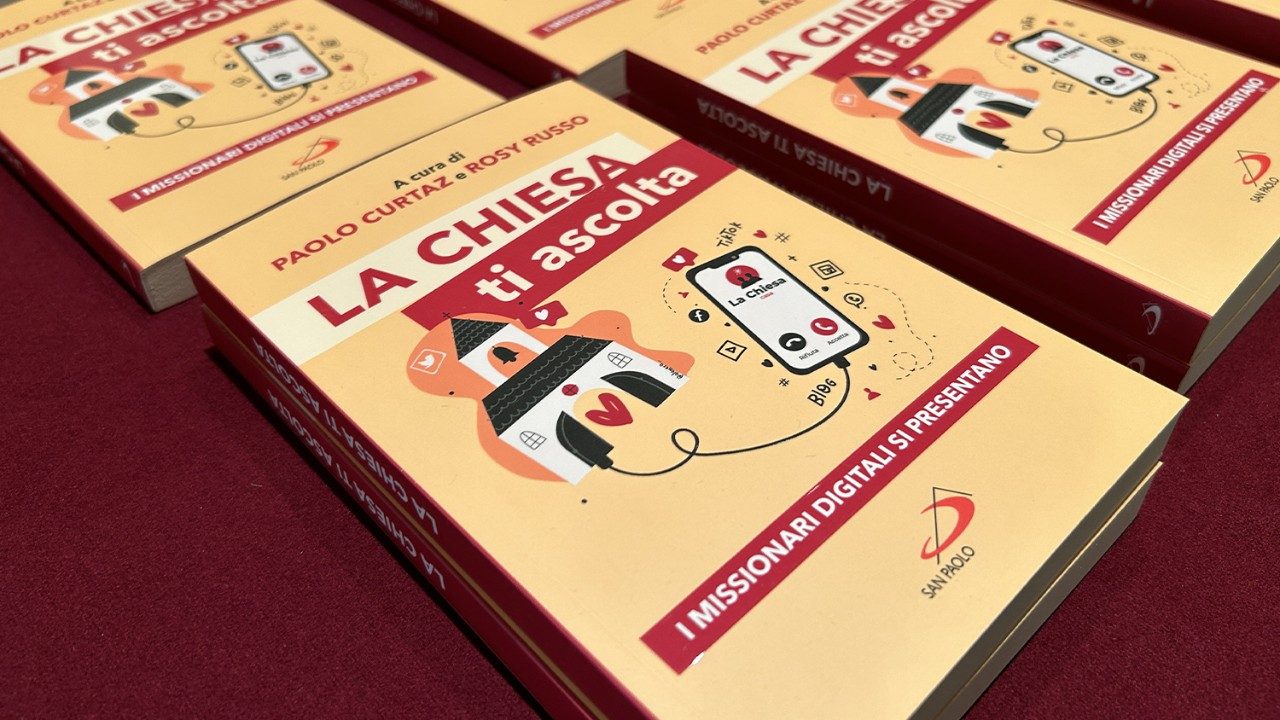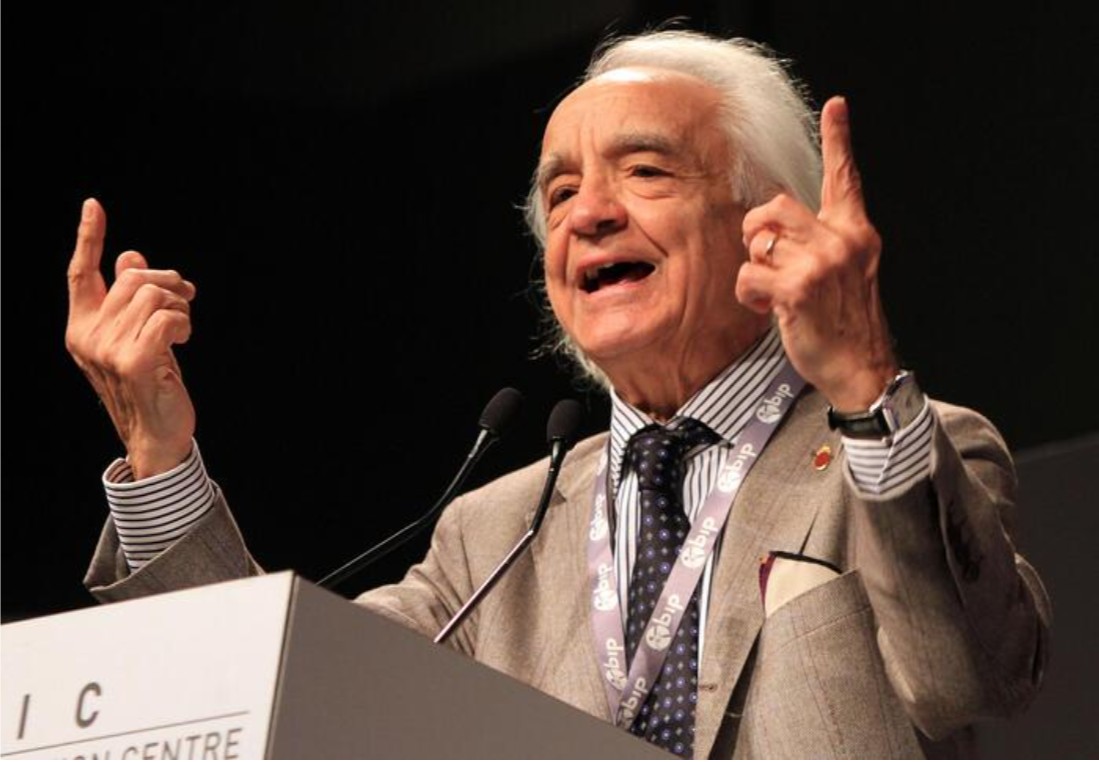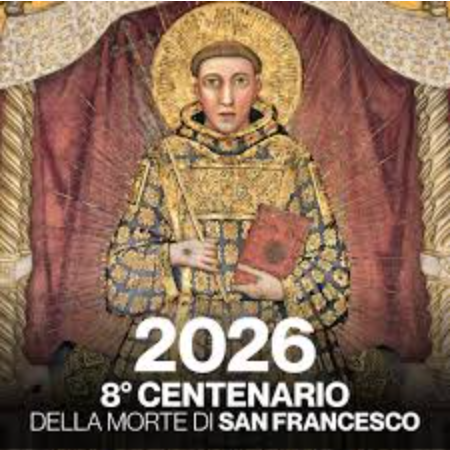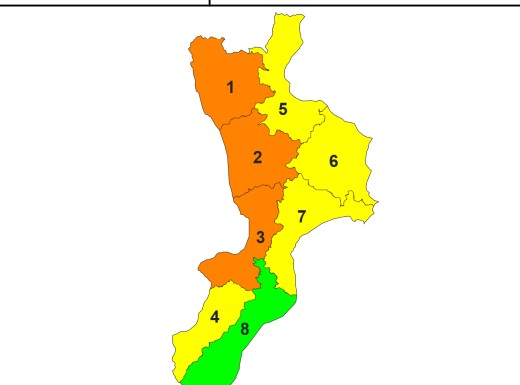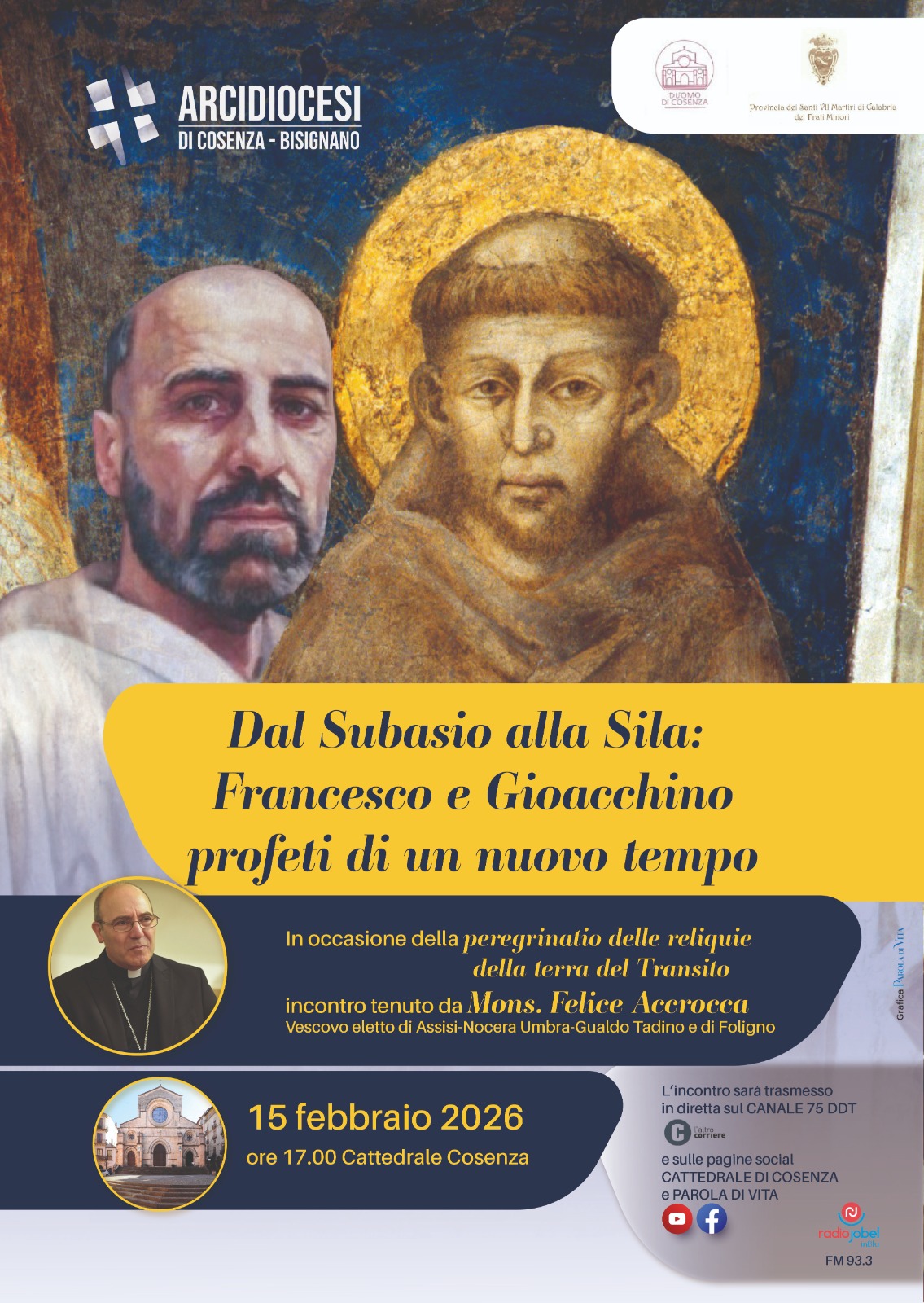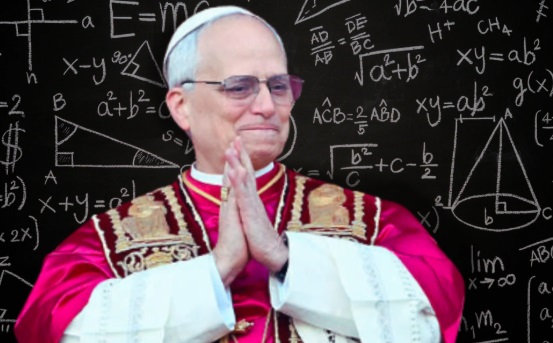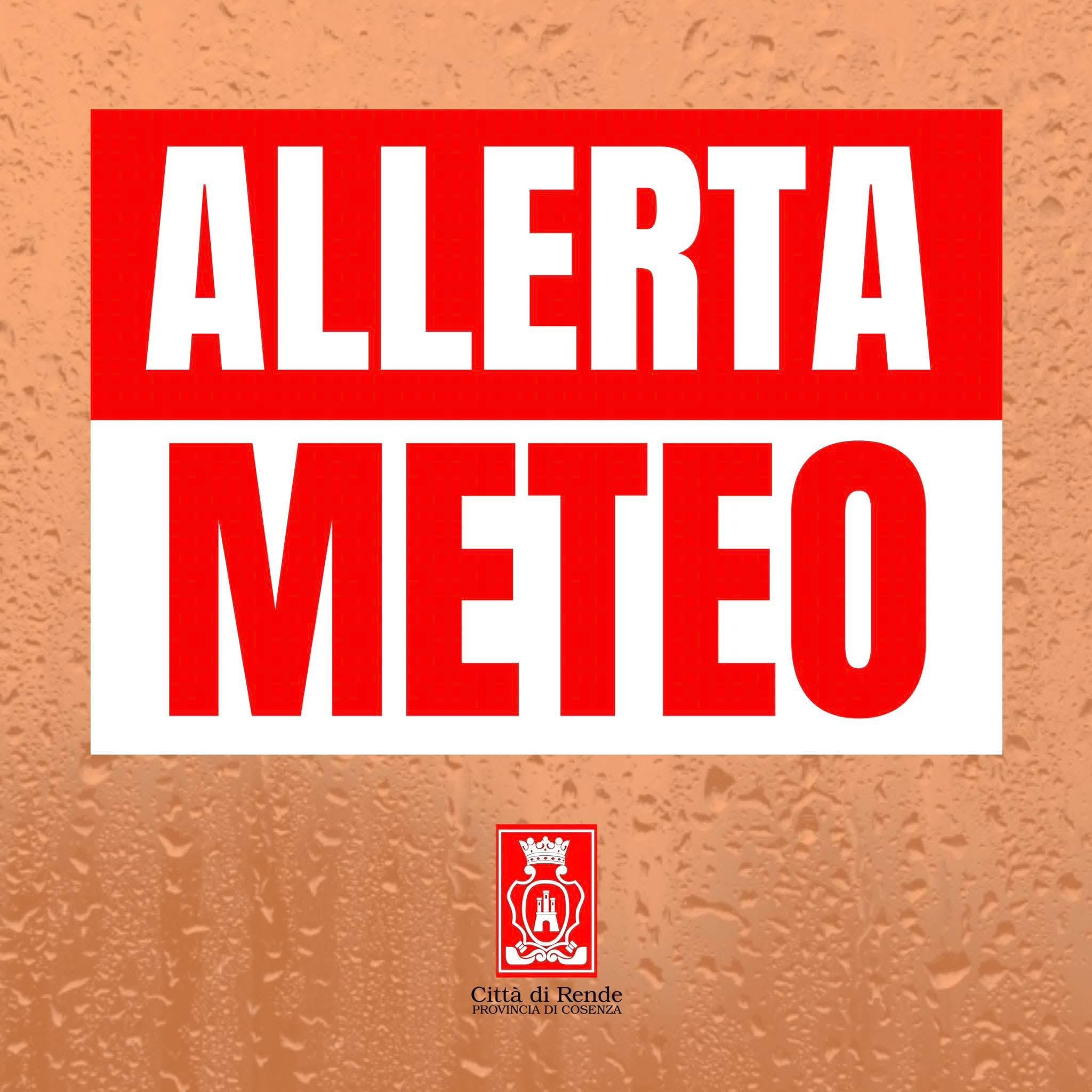Chiesa
Storia e glossario del Conclave

La Costituzione “Ubi periculum” di Gregorio X codificò le norme per il regolare svolgimento dell’assemblea
Dal tardo latino cum clave (composto da “con” + “clavis” ovvero “sottochiave” o “chiuso a chiave”), il termine Conclave designa una camera chiusa a chiave nella quale, storicamente, si riunisce l’assemblea dei cardinali convocati per eleggere il nuovo Pontefice. Con la bolla In nomine Domini del 12 aprile 1059, Niccolò II aveva riservato ai soli cardinali e vescovi l’elezione del nuovo Vicario di Cristo, stabilendo in un secondo momento la possibilità che potessero aggiungersi anche il clero e i laici. In caso di impossibilità a raggiungere la Città Eterna per l’adunanza del consesso, la norma consentiva di scegliere anche un altro luogo, come la Cattedrale della città dove era morto l’ultimo Papa. Dopo le votazioni i candidati tornavano nelle loro residenze in città e in zone limitrofe. La prima elezione del Sommo Pastore, in un luogo chiuso e isolato dal popolo, fu quella del 1118, quando i porporati si ritrovarono, per libera scelta, nel Monastero di San Sebastiano sul colle Palatino a Roma, votando per Gelasio II. Nel marzo 1179 Alessandro III convocò il Terzo Concilio Lateranense, nell’ambito del quale venne promulgata la Costituzione Licet de evitanda che stabilì, una volta per tutte, che solo i cardinali avessero diritto a scegliere il nuovo Papa, escludendo esplicitamente i laici, e che l’elezione dovesse avvenire con una maggioranza di almeno i due terzi per essere ritenuta valida. Il termine Conclave fu impiegato per la prima volta nel 1216, quando Onorio III salì al Soglio Pontificio, dopo la morte di Innocenzo III. Poiché i cardinali, riunitisi a Perugia, dove era morto l’ultimo Successore di Pietro, non si accordavano sulla persona da eleggere, i Perugini decisero di chiuderli a chiave per affrettarne le decisioni. Analogo episodio si verificò, pochi decenni dopo, a Viterbo nel 1271, quando si giunse a scoperchiare il tetto del Palazzo Papale in cui erano stati segregati a chiave gli alti prelati, poiché costoro, dopo quasi tre anni, non avevano ancora scelto un nome. Sarebbe stato eletto Gregorio X che dettò, durante il Secondo Concilio di Lione nel 1274, una serie di norme e di leggi per l’elezione papale, che confluirono nella Costituzione Ubi periculum, concepita per evitare quanto accaduto per la sua stessa nomina. I prelati furono obbligati a riunirsi tutti in clausura in una stessa sala comune senza avere contatti esterni, a ritrovarsi nello stesso luogo in cui era deceduto l’ultimo Capo della Chiesa, con al seguito un solo accompagnatore ciascuno, a non ricevere scritti o lettere, pena la scomunica, a dormire in stanza con un collega e, dopo tre giorni, a consumare un solo pasto giornaliero. Quanto deciso da Gregorio X restò in vigore per secoli. Risale al 1503 il Conclave più breve della durata di 10 ore, terminato il quale venne eletto Giulio II, fondatore dei Musei Vaticani e della Guardia Svizzera, nonché artefice dei primi lavori per l’edificazione della Basilica di San Pietro e promotore delle opere di Michelangelo e Raffaello. Nel 1621 Gregorio XV rafforzò la segretezza del voto imponendo la maggioranza dei due terzi (oggi in vigore), e rendendo più difficile il ricorso alla nomina per acclamazione o per compromesso. Pur ripetendosi da secoli, queste regole hanno subìto delle modifiche, come quelle introdotte, in epoca moderna, da San Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI. Nel 1996 il Papa polacco varò la Costituzione Apostolica Universi Domini Gregis, con cui stabilì che l’elezione doveva avvenire solo attraverso lo scrutinio segreto, con quattro votazioni giornaliere, escludendo l’acclamazione popolare. Se al trentaquattresimo scrutinio non c’era ancora il nome, si poteva procedere all’elezione per maggioranza assoluta, votando i due candidati che, nella precedente tornata, avevano ottenuto i maggiori suffragi. Ratzinger, con il Motu Proprio De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis del 2007, estese la regola dei due terzi dei voti anche per l’eventuale ballottaggio e, con il Motu Proprio Normas nonnullas del 2013, ribadì il precetto secondo cui, prima di iniziare il Conclave, si dovevano attendere per quindici giorni i cardinali assenti, dando però la possibilità al Collegio cardinalizio di anticipare la data di inizio, qualora tutti i porporati fossero stati presenti in anticipo, o di prorogarla fino ad un massimo di venti giorni per attendere gli assenti. Durante la Sede Vacante i cardinali non possono né emanare né modificare alcuna legge, tranne che per casi urgenti, che vengono decisi dal Sacro Collegio con maggioranza di voti. È proibito l’uso dei telefoni e la lettura dei giornali, per impedire influenze da parte di terzi. Sede esclusiva dei Conclavi, in età moderna, è la Cappella Sistina, con l’eccezione di Pio VII che fu eletto nel 1800 a Venezia e nel XIX secolo, fino al 1870, la sede fu il Palazzo del Quirinale. La Costituzione Vacantis Apostolicae sedis (1945) di Pio XII impose che l’assemblea doveva riunirsi in territorio vaticano, al massimo entro 20 giorni dalla morte del Papa. Paolo VI, con il Motu Proprio Ingravescentem aetatem del 1970, decise che il numero massimo dei candidati elettori doveva essere 120 (elevato poi da Papa Francesco a 135), e che questi dovevano avere un’età inferiore agli 80 anni. Tutti i cardinali elettori raggiungono la Capitale, in seguito all’invito del cardinale decano, e si radunano a San Pietro, partecipando alla messa pro eligendo Romano Pontefice, ovvero “per l’elezione del pontefice”, invocando lo Spirito Santo affinché li indirizzi nella scelta del nuovo Papa. Dopo le preghiere di rito si dirigono nella Cappella Sistina, luogo dove si svolse il primo consesso nel 1492, che portò all’elezione di Alessandro VI, e dove si svolge ormai stabilmente dal 1878. La scelta di questa meravigliosa cornice è dovuta alla sua importanza come uno dei luoghi più sacri della Città del Vaticano, ubicato dentro il Palazzo Apostolico. La Cappella Sistina offre un ambiente sicuro e isolato ai cardinali, permettendogli di scegliere il nuovo Papa senza influenze esterne e, infine, con le sue opere d’arte rinascimentali, tra cui gli affreschi michelangioleschi come il Giudizio universale, rappresenta la continuità tra la Chiesa cattolica e la sua storia. Qui i porporati giurano solennemente in latino di non rivelare mai cosa accade durante l’adunanza. Segue la dichiarazione “extra omnes” (fuori tutti) del maestro delle celebrazioni liturgiche, per cui coloro che non hanno diritto a partecipare devono uscire. Chiuse le porte iniziano i lavori, che prevedono fino ad un massimo di quattro votazioni al giorno. Nel corso del Conclave i porporati alloggiano presso la Domus Sanctae Marthae, fatta costruire da Wojtyla nel 1996 dentro lo Stato Vaticano, e ultimata in tempo per il Conclave del 2005. Fino al 1978 venivano alloggiati in alcuni dormitori provvisori, molto spartani e spesso privi di gabinetti privati, messi in piedi per l’occasione nelle varie stanze del Palazzo Apostolico. La nuova residenza voluta da San Giovanni Paolo II assicura invece riservatezza e comfort durante il periodo dell’elezione. È con la pronuncia della formula “habemus papam” che viene consegnato, al mondo cristiano, il nuovo Capo della Chiesa. Il rito preserva ancora l’aura di mistero che l’ha sempre contraddistinto.