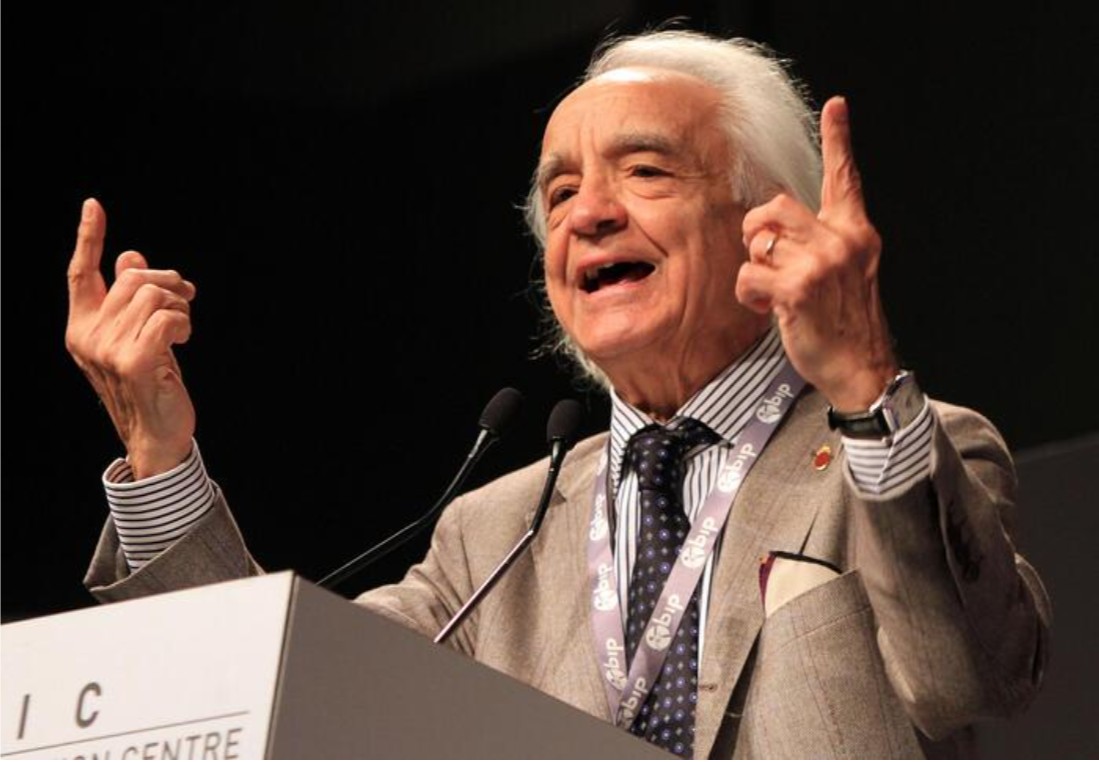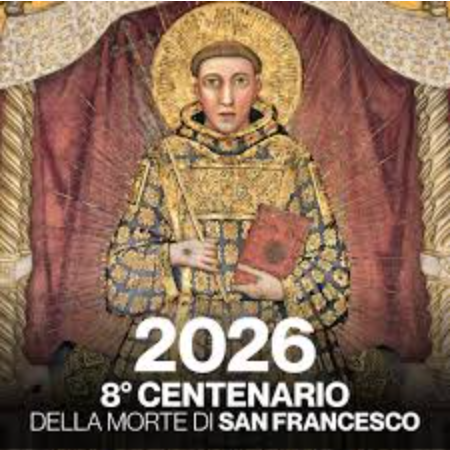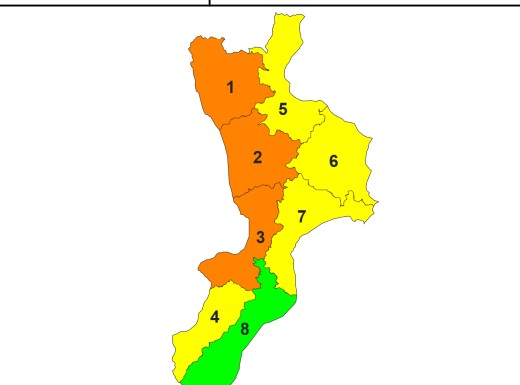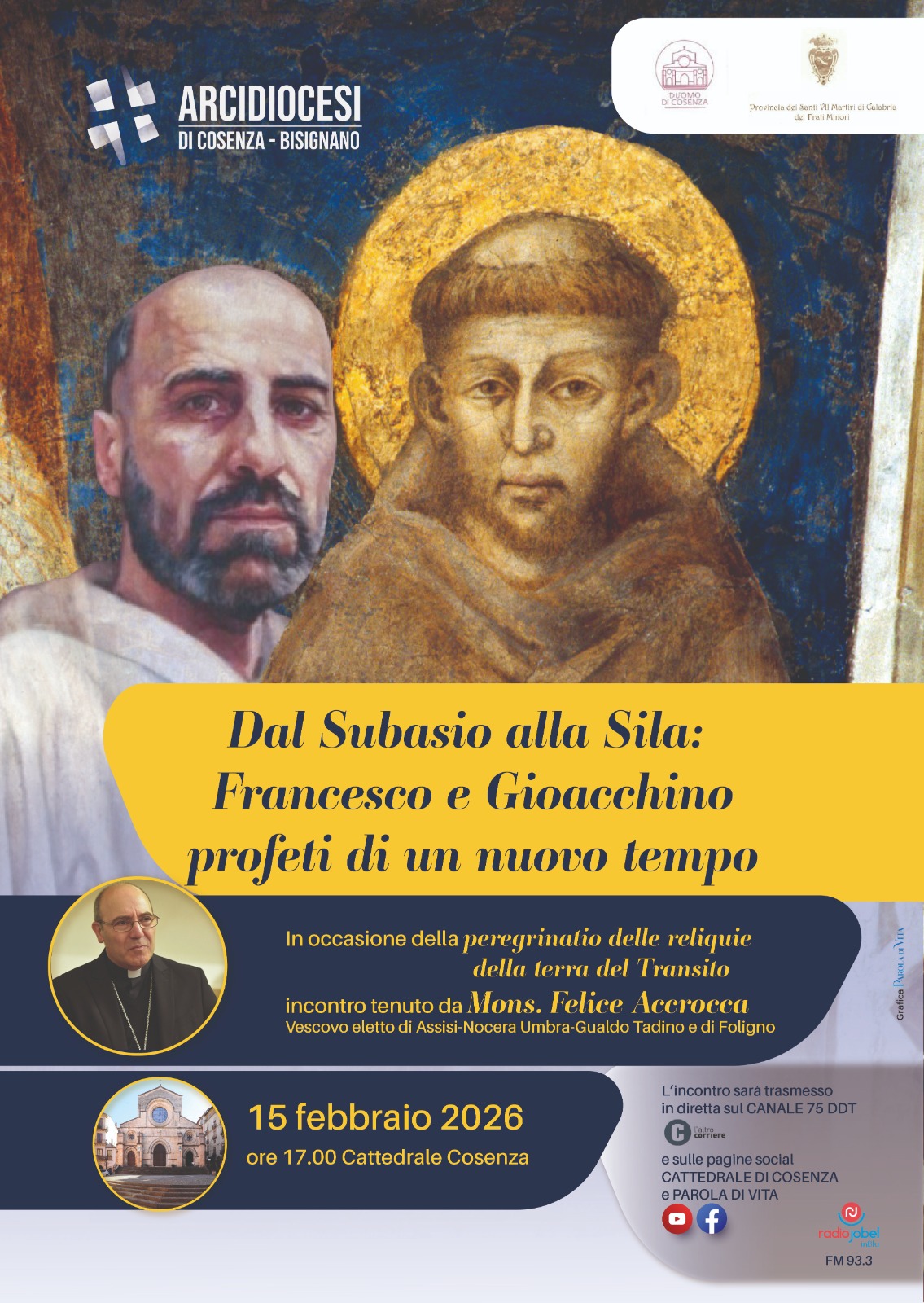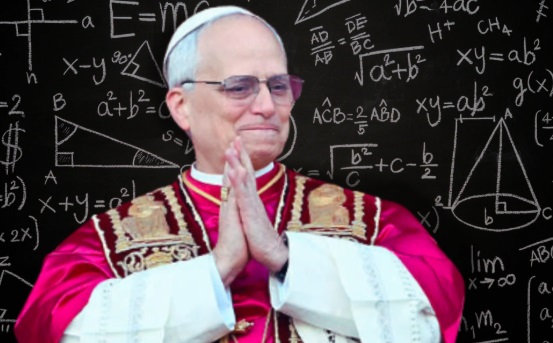Cultura
La Scala Santa e il Sancta Sanctorum

I pellegrini possono ottenere sempre l’indulgenza plenaria salendo questa Scala
Un sacro simbolo che ricorda la Passione di Cristo è il Sancta Sanctorum, situato in prossimità della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. I pellegrini possono ottenere l’indulgenza dai loro peccati tutti i giorni dell’anno, al di là del Giubileo della Speranza ora in corso, visitando questo luogo santo e accostandosi ai sacramenti della Confessione e della Comunione, professando il Credo o pregando per il Papa. Fu con la bolla Cum rerum singolarum, emanata da Papa Sisto V nel 1590, che venne istituito questo Santuario a cui fu conferito questo speciale riconoscimento. Al Sancta Sanctorum si giunge salendo la famosa “Scala Santa” che, secondo la tradizione, è la stessa che salì e discese più volte Gesù per raggiungere il Pretorio di Gerusalemme, dove subì l’interrogatorio da parte di Ponzio Pilato. Non esistono prove scientifiche che possano comprovare la conformità di questa reliquia monumentale con quella risalente all’epoca del Redentore, ma la devozione cristiana, tramandatasi fin dal Medioevo, induce i fedeli a credere che l’identificazione sia più che certa. Il suo trasporto nell’Urbe, risalente al 326, è opera di Sant’Elena, madre di Costantino, che compì un viaggio in Terra Santa alla ricerca delle reliquie della Passione di Cristo. L’anno prima di emettere la bolla papale, Sisto V chiese all’architetto Domenico Fontana di traslare i preziosi 28 gradini marmorei, dal vecchio Patriarchio, Sede Apostolica prima del periodo della cattività avignonese, al lato sinistro della piazza di San Giovanni in Laterano, dove si trovano ancora oggi, divenendo parte di un complesso noto come “Pontificio Santuario della Scala Santa”, comprendente anche la Chiesa di San Lorenzo in Palatio ad Sancta Sanctorum. Dal 1854 questi 28 gradini, per volontà di Pio IX, sono custoditi dai Religiosi Passionisti, il cui scopo è quello di tener viva la memoria del Sacrificio di Gesù. La Santa Scala, posta al centro tra altre quattro scale, è abbastanza faticosa da salire. Ascenderla in ginocchio è un atto di umiltà, di penitenza, di pietà e di fede che giova ai credenti, i quali fanno memoria delle atroci sofferenze patite dal Signore, e ricordano la più grande storia d’amore sacrificale che il mondo abbia mai conosciuto. Nel 1724 Papa Innocenzo XIII ordinò di riporre sui gradini una copertura in legno di noce, per oscurare i solchi scavati dalle punte dei piedi dei pellegrini e, soprattutto, dalle loro ginocchia. Nel 2019 la rimozione della copertura lignea, destinata a una pulitura e ad un restauro accurati, ha svelato la veste originaria in marmo bianco orientale, e ha portato al ritrovamento di biglietti, crocifissi, rosari e immaginette, riposte sotto di essa da chi chiedeva una grazia a Dio. Sul secondo, sull’undicesimo e sull’ultimo gradino ci sono degli oblò di vetro, osservando i quali si notano delle croci in ottone e marmo su cui, secondo la tradizione sviluppatasi specialmente durante il Medioevo, le persone intravidero delle gocce di sangue attribuite a Cristo, oggetto di venerazione. I fedeli, ancora oggi, si fermano, lasciano oggetti, posano il loro capo pensando al martirio di Gesù, che ci ha donato la salvezza. L’indulgenza plenaria può essere ottenuta anche dagli ammalati con difficoltà motorie, i quali possono salire con i loro supporti lungo una montascale, installato su una delle quattro scale che attorniano quella santa, pregando Dio. Salendo i gradini, il pellegrino può ammirare un complesso di 33 affreschi che ritraggono le ultime ore del Figlio di Dio, mentre altre 75 opere a tema biblico, realizzate da 12 pittori su richiesta di Sisto V, abbelliscono le pareti di due delle scale laterali. Completata l’ascesa si giunge al “Sancta Santorum”, la Cappella di San Lorenzo in Palatio, un tempo parte del Patriarchio.

Definita la “Cappella Sistina dei primi tempi”, era il tempietto privato del Papa da cui partiva la processione, che conduceva il nuovo Pontefice eletto all’intronizzazione nella Basilica di San Giovanni. Vi si svolgevano alcune delle funzioni religiose della Settimana Santa e, con molta probabilità, in questo sacello Bonifacio VIII indisse per la prima volta il Giubileo nel 1300. La porta in bronzo, che chiude la Cappella, immette in una stanza adornata da elementi gotici e affreschi della Scuola Romana, commissionati da Papa Niccolò III nel duecento. Il pavimento cosmatesco è ricoperto da un mosaico di porfido, granito e marmo colorato. In questo sacrario svetta la celebre Icona “Acheropita” (non dipinta da mani umane) che raffigura Cristo in trono, rivestita da lastre d’argento. È il “Santissimo Salvatore”, da cui derivò anche il nome dato alla Basilica Lateranense, risalente alla fine del V e inizi del VI secolo, di cui non si conosce il nome dell’autore, né tanto meno sono chiare le vicende che la condussero a Roma. La tradizione vuole che il lavoro fu iniziato dall’evangelista Luca e completato dagli angeli. In passato i Papi erano soliti, la mattina della Domenica di Pasqua, recarsi nel Sancta Sanctorum per assistere all’apertura delle ante (Anastasis) che celavano quest’icona, un chiaro rimando simbolico a Gesù Risorto che esce dal sepolcro. Inoltre, la notte del 14 agosto la medesima effige veniva portata in processione, attraverso il Foro Romano e fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove all’alba si ricongiungeva all’immagine della “Salus Populi Romani”, l’icona bizantina raffigurante la Vergine col Bambino, conservata nella Cappella Paolina di questa Basilica. Sotto l’immagine è presente un altare di epoca carolingia, sul quale solo il Sommo Pontefice può celebrare l’Eucaristia. È racchiusa da porte bronzee, su cui sono visibili le immagini di Pietro e Paolo, e protetta da una poderosa grata di ferro con lucchetti, tanto sicura da renderla una cassaforte. All’interno vi è un’arca cipressina con reliquie dei santi dei primi secoli e di Gesù. La parete antistante la porta di ingresso del Sancta Sanctorum presenta un reliquiario ligneo e in cristallo, nel quale è custodito un frammento del legno del triclinio su cui sedeva Gesù durante l’Ultima Cena. Questo luogo può essere visitato solo portando con sé fede e amore in Dio, nella consapevolezza che Colui che è morto in Croce ci chiede penitenza e conversione del cuore.