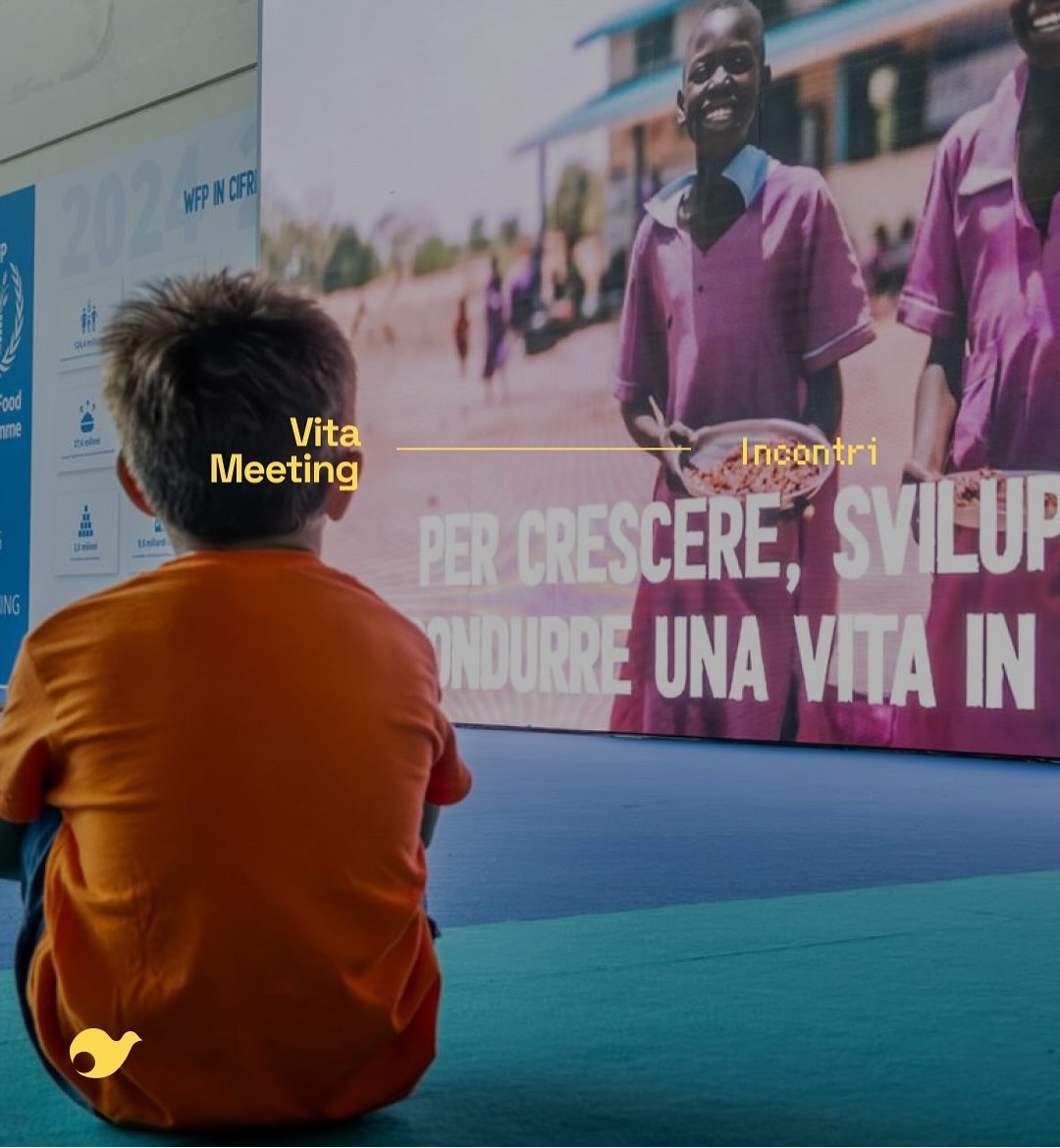Attualità
Effetti dell’inflazione. Boitani (Un. Cattolica): “Indicizzare subito gli scaglioni di reddito per recuperare potere d’acquisto”

“La finanza pubblica ha beneficiato del ‘fiscal drag’, che è esattamente ciò che ha rovinato le famiglie”, commenta il docente. Bisognerebbe intervenire con la prossima Legge di bilancio sugli scaglioni di imposta “reperendo le risorse necessarie a contenere il deficit in altro modo”
“Se i prezzi dei beni alimentari e dei beni di prima necessità aumentano più degli altri il potere d’acquisto dei salari più bassi si riduce ulteriormente”. Lo sottolinea Andrea Boitani, professore ordinario di Economia politica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, commentando i recenti dati forniti dall’Istat sull’inflazione in Italia che, ad agosto, è scesa all’1,6%, principalmente per effetto della flessione dei prezzi dei Beni energetici (-4,8% da -3,4% di luglio). Accelerano invece i prezzi nel settore alimentare (+3,8% da +3,7%); ad agosto, inoltre, si è registrata una crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” (+3,4% da +3,2%) e, seppure in misura modesta, l’inflazione di fondo (+2,1% da +2,0%).
Professore, come giudica i dati diffusi dall’Istat?
È fuori discussione che l’inflazione all’1,6% è bassa; l’obiettivo fissato dalla Banca centrale europea è del 2%, quindi siamo al di sotto. Siamo di fronte a valori che si erano raggiunti nel periodo della grande recessione, dopo il 2011-2012; valori per i quali, ad un certo punto, si è deciso di varare il Quantitative Easing da parte della Bce con l’acquisto di titoli di Stato o altre obbligazioni sul mercato per riportare l’inflazione a livello obiettivo intorno al 2%.
Il fatto che la riduzione più recente dell’inflazione sia dovuta essenzialmente al crollo dei prezzi dell’energia ci dice che gli attuali bassi livelli d’inflazione potrebbero cambiare rapidamente; è sufficiente qualche shock relativo ai prezzi del petrolio, del gas…, perché l’inflazione torni a salire anche oltre il 2%.
I prezzi di petrolio e gas sono per conto proprio volatili, in generale più dell’inflazione di fondo che, come si è visto, è rimasta molto stabile.
Sull’economia italiana non si è ancora fatto sentire l’impatto dei dazi imposti dall’Amministrazione statunitense. Quali potrebbero essere le conseguenze?
I dazi negli Usa hanno un effetto ripartito sui pezzi al consumo, sui margini degli importatori e sui margini degli esportatori; questi ultimi devono fare inoltre i conti con le quantità esportate. Gli esportatori verso gli Usa devono scegliere cosa costa loro di meno: se ridurre i prezzi in modo da mantenere le quantità vendute all’estero oppure se rivedere le quantità prodotte, poiché aumentando il prezzo per chi acquista la domanda sarà più bassa.
Anche in Italia gli effetti prima o poi ci saranno, nel senso che gli esportatori avranno una qualche riduzione delle esportazioni. Questa potrà essere compensata con esportazioni verso altri Paesi oppure provocherà un calo del Pil se non aumenteranno i consumi interni. A cascata ne risentirebbe l’occupazione e si potrebbe registrare un’ulteriore riduzione del tasso di inflazione medio.
Questo vale per tutti i Paesi europei che hanno come rilevante mercato di sbocco gli Stati Uniti. Per l’Italia bisogna tener conto anche di un altro aspetto…
Quale?
Nel nostro Paese, per esempio, ci sono aziende che producono parti che vengono utilizzate dai produttori di automobili non solo in Italia ma anche in Germania. I tedeschi, come noi, subiscono gli stessi dazi americani. Le imprese italiane che producono parti e non le esportano direttamente negli Stati Uniti ma in Germania – perché qui si realizzano prodotti che poi vengono venduti negli Usa – subiranno anche loro un effetto che sarà sempre un po’ sul prezzo e un po’ sulla quantità.
Anche ad agosto si è registrata la crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa”, un andamento che segue quello registrato per i prezzi al consumo (indice armonizzato) dei beni alimentari (cibo e bevande non alcoliche) aumentati a luglio del 30,1% rispetto a quello medio del 2019…
La crescita si colloca sopra il 3% e rappresenta un problema, perché le spese per beni alimentari e quelle imprescindibili per la vita quotidiana – trasporti, cura della casa e della persona… – sono relative a beni i cui prezzi salgono oltre il tasso d’inflazione obiettivo e oltre quello misurato dell’1,6%. Questo ha
l’effetto di ridurre il potere d’acquisto dei salari e degli stipendi in misura molto superiore all’inflazione media.
E sono soprattutto i salari più bassi in generale ad acquistare questo tipo di prodotti dei quali non si può fare a meno. Questo fatto non è direttamente misurato dalle statistiche ufficiali, ma è possibile misurare l’ulteriore riduzione dei salari reali. Che, come sappiamo, in Italia sono cresciuti a partire dal 2022 ma in misura molto contenuta e, nelle rilevazioni di maggio-giugno, erano ancora inferiori a quelli del 2021 e non di poco;
insomma, il fatto che i prezzi dei beni alimentari e dei beni di prima necessità aumentino più degli altri, fa sì che effettivamente il potere d’acquisto dei redditi più bassi si vada ulteriormente riducendo.
In questo contesto, Bankitalia ha detto che il debito pubblico a luglio è calato a 3.056,3 miliardi (-14,5 miliardi rispetto al mese precedente) e le entrate tributarie sono aumentate del 13% rispetto al 2024, toccando quota 68,3 miliardi. In vista della Legge di bilancio quali sono le politiche economiche da mettere in atto?
Quello che è chiaramente successo in Italia in questi anni, e questo si riflette nell’aumento delle entrate tributarie, è che s’è lasciato operare il “fiscal drag”, il drenaggio fiscale: i redditi sono aumentati, non molto per la verità, in termini nominali e gli scaglioni di imposta sono rimasti quelli che erano prima. Questo ha fatto aumentare la pressione fiscale, nel senso che una parte dei redditi è finita in scaglioni per i quali l’aliquota è più elevata e quindi hanno pagato maggiori tasse nonostante il potere d’acquisto effettivo di quegli stessi redditi non fosse aumentato.
La finanza pubblica ha beneficiato del “fiscal drag”, che è esattamente ciò che ha rovinato le famiglie.
È stato un modo per certi versi silenzioso di aggiustare le finanze pubbliche. Lo si è fatto con una “tassa da inflazione”, già dal 2022 quando l’inflazione ha cominciato a rialzare la testa. Finora tutte le proposte che andavano nella direzione di annullare il “fiscal drag”, indicizzando gli scaglioni e cercando di restituire quello che era stato preso grazie all’inflazione negli anni precedenti, sono cadute nel nulla. Secondo me
quello che la Legge di bilancio dovrebbe fare è indicizzare subito gli scaglioni. E ovviamente reperire le risorse necessarie a contenere il deficit in altro modo.