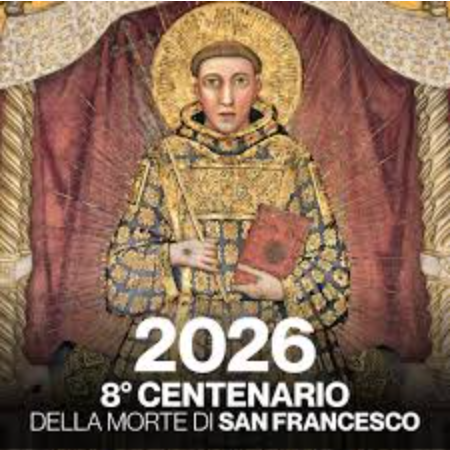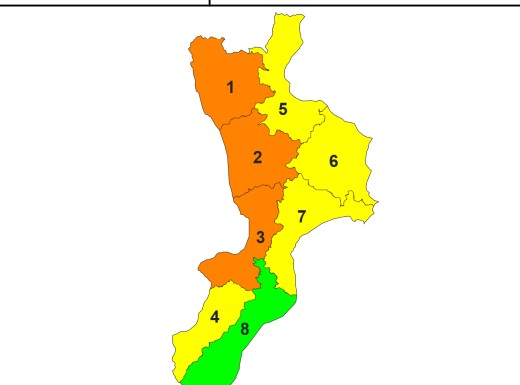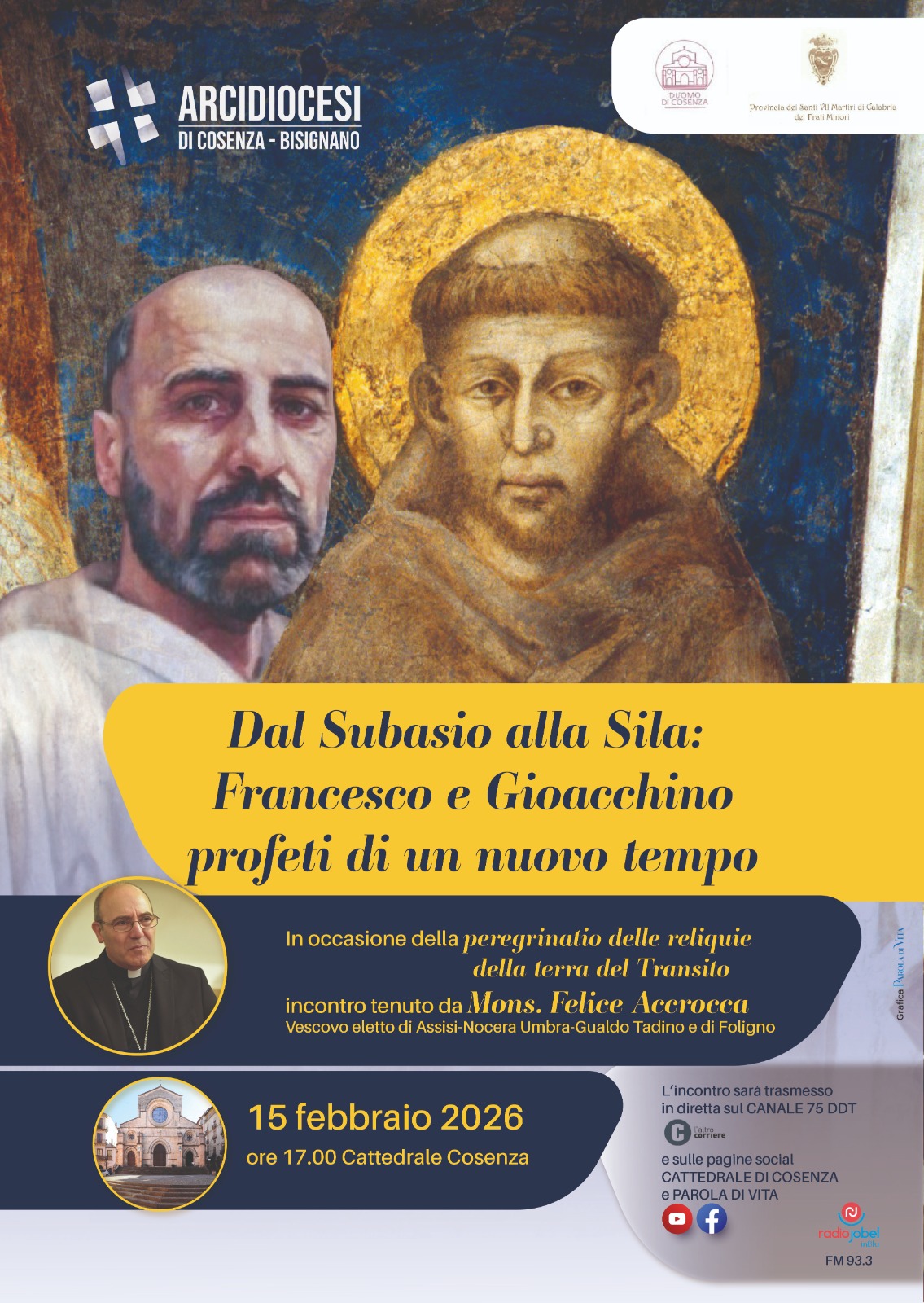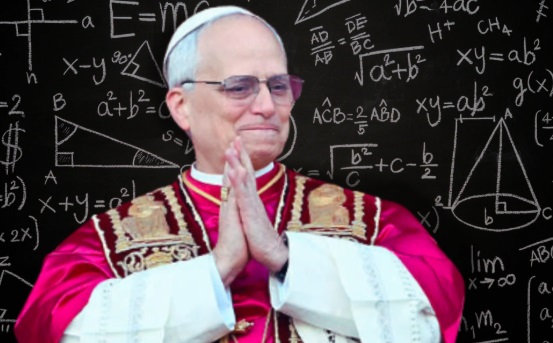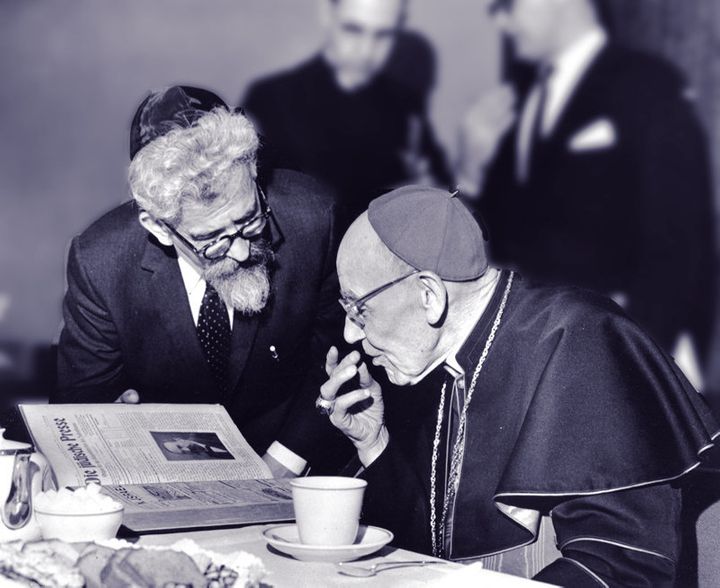Cultura
Duonnu Pantu, il sacerdote e poeta proibito di Aprigliano

Il sacerdote aveva uno stile provocatorio con cui attaccò il potere costituito del suo tempo
Un calabrese che merita un posto di rilievo nelle pagine di storia locale è don Domenico Piro, noto anche come “Duonnu Pantu”. Nel volume di recente pubblicazione dal titolo Duonnu Pantu e i Gapulieri. Studio documentario inedito su identità e attribuzione poesie (The Writer 2025), a cura di Tonino De Paoli, viene presentata un’immagine del tutto nuova e veritiera di questo presbitero, che smonta gli stereotipi negativi perpetrati nei secoli. Dalle scarse informazioni che possediamo sul suo conto, sappiamo che don Domenico nacque verso il 1660 ad Aprigliano, in provincia di Cosenza, e qui morì nel 1696. Crebbe in una nobile famiglia che viveva nella frazione Santo Stefano, i cui membri erano dediti alla professione forense. Alcuni dati biografici sono stati ricostruiti a partire dai contatti che Piro aveva con altre persone, in particolare con il fratello Isidoro, l’ “eruditissimus”, con i fratelli Donato, suoi cugini, e con l’amico e letterato Carlo Cosentini, ricordato per essersi occupato della traduzione in dialetto calabrese della Gerusalemme Liberata di Tasso. Duonnu Pantu fu un sacerdote anticonformista di grande cultura, nonché il primo poeta dialettale in Calabria. La sua unica colpa fu quella di scrivere componimenti con un linguaggio diretto e senza fronzoli, sfidando addirittura la Chiesa controriformista che, in risposta alla riforma luterana, fece leva sulla repressione interna dei dissidenti e su maggiori puntualizzazioni dogmatiche e organizzative. Come sottolinea De Paoli nel suo studio, don Piro impiegò uno stile provocatorio nelle sue poesie per denunciare le oppressioni e le ingiustizie sociali del tempo, causate dalle autorità a danno del popolo. Per questo motivo si dilettava, insieme ai cugini, i fratelli Ignazio e Giuseppe Donato, ad elaborare le “pasquinate”, battute mordaci, satiriche, fulminanti dirette a personaggi o istituzioni pubbliche, nate nel Cinquecento a Roma e durate almeno fino all’Ottocento, cioè fino alla fine del potere temporale della Chiesa. I poeti che le scrivevano erano uomini colti noti con il nomignolo di “gapulieri” o criticoni, perennemente attaccati dalla Santa Sede perché ritenuti pericolosi. Quella di Piro, quindi, è una lirica viva e liberatoria, priva di falsi moralismi, realista e spontanea, legata a tematiche popolari e giocose con cui combatteva le sue battaglie, andando perfino contro l’animo rassegnato di tanti calabresi. Era solito calarsi nella quotidianità di tutti i giorni per conoscerla da vicino e per apprendere modi di dire e vocaboli. Scendeva, ad esempio, nel mercato di Cosenza per imparare parole ed espressioni usate dal popolo, che definì “lazzi e motti arguti”. Nel suo componimento in ventuno ottave, “La Cazzeide”, Duonnu Pantu azzarda un confronto tra l’epoca nella quale visse lui, il XVII secolo, caratterizzato da licenziosità e lussuria, e l’età dell’oro dominata dall’innocenza e dall’amore spirituale tra le persone. Il poeta addossa la colpa alla dea Venere, offesa da Giunone in collera con lei, e condanna le donne al massimo della dissolutezza. La donna cerca rapporti carnali e tradisce il marito, senza curarsi di età, grado sociale o razza. “Quannu jurìa la bella età de l’uoru, Chi a Saturno li figli secutaru, Tannu lu cunnu valìa nu trisuoru, Era musca ogni figlia de craparu. Stàvanu tutti cuomu frati e suoru”, scrive il poeta. Tra le altre sue poesie ricordiamo “Lu mumuriali”, “La cunneide”, “Jisti a de Pinnu”, “La pruvvista” e “Briga de li studienti” e “Fratemma”. L’allora vescovo di Cosenza, mons. Gennaro Sanfelice, lo apprezzava come poeta ma disapprovava i suoi scritti che tentò di sottoporre a censura, per via del loro contenuto apparentemente scabroso che colpiva al cuore la moralità del tempo. Di queste “poesie proibite” fu vietata la pubblicazione e l’intellettuale fu perfino arrestato. L’amore per la scrittura, tuttavia, accompagnò i giorni di questo sfortunato poeta. Nel testo “Canzuna” parla della condizione del rimatore che vive nutrendosi di versi. Si legge: “Fràtimma dice ca nun vale l’uoru, ca ccu’ lu litteratu nun cc’è paru, Io vurria truvare nu trisuòru. ppe’ dire buonanotte allu livraru”. Sono queste parole nelle quali è racchiusa l’eterna tensione tra arte e sopravvivenza, tra scrivere e desiderio di vivere. Tonino De Paoli ha voluto riaccendere i riflettori su una delle personalità più belle e interessanti della tradizione poetica calabrese, giovandosi di precedenti ricerche compiute da studiosi come Luigi Gallucci, Giuseppe Candido e Filippo Curtosi.