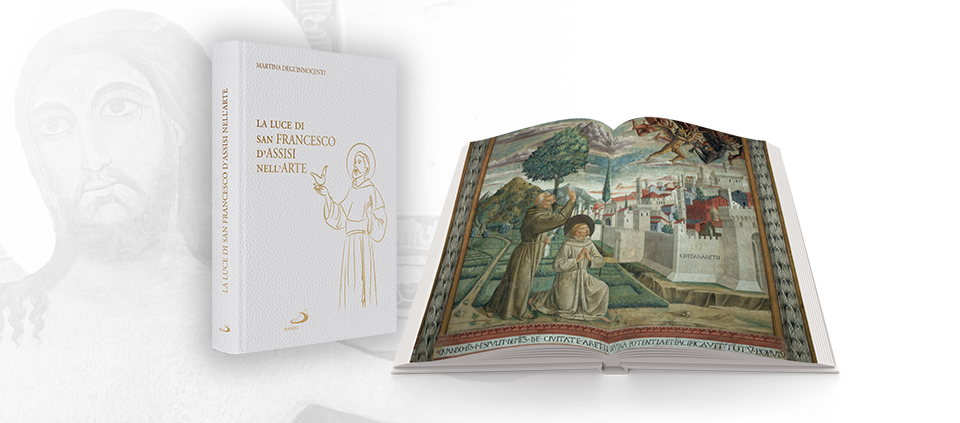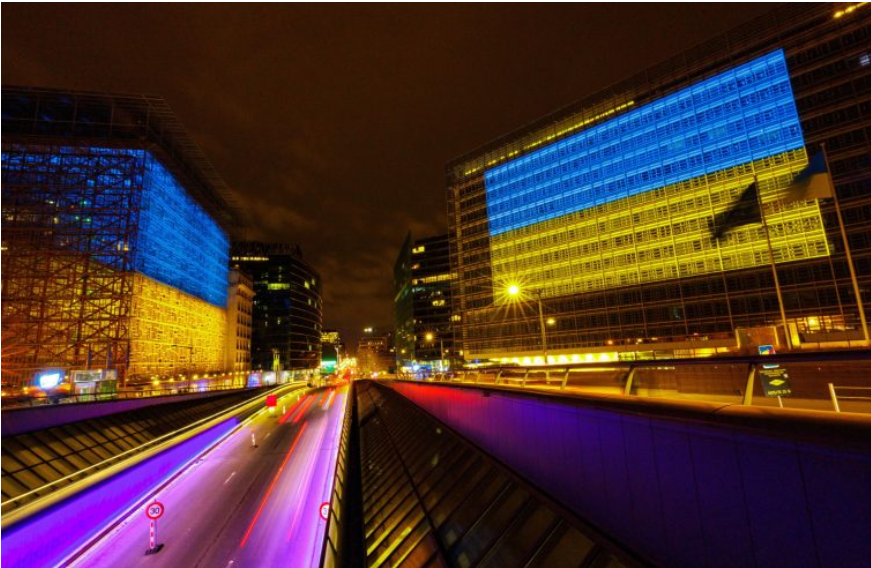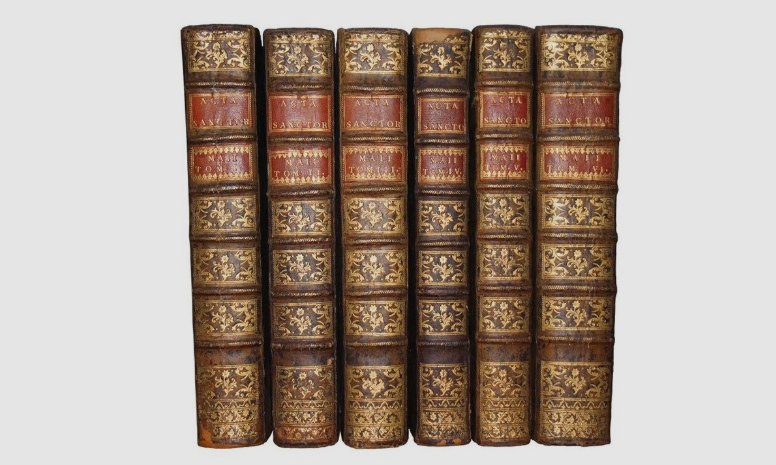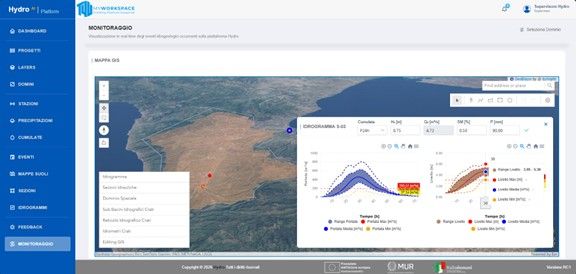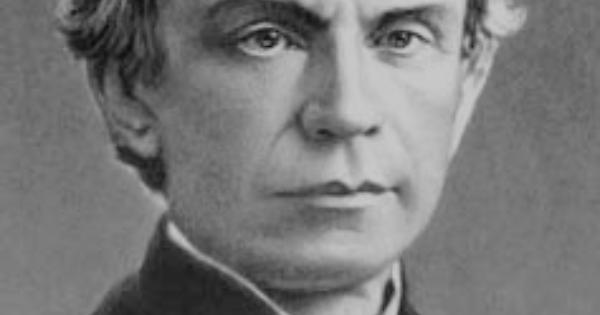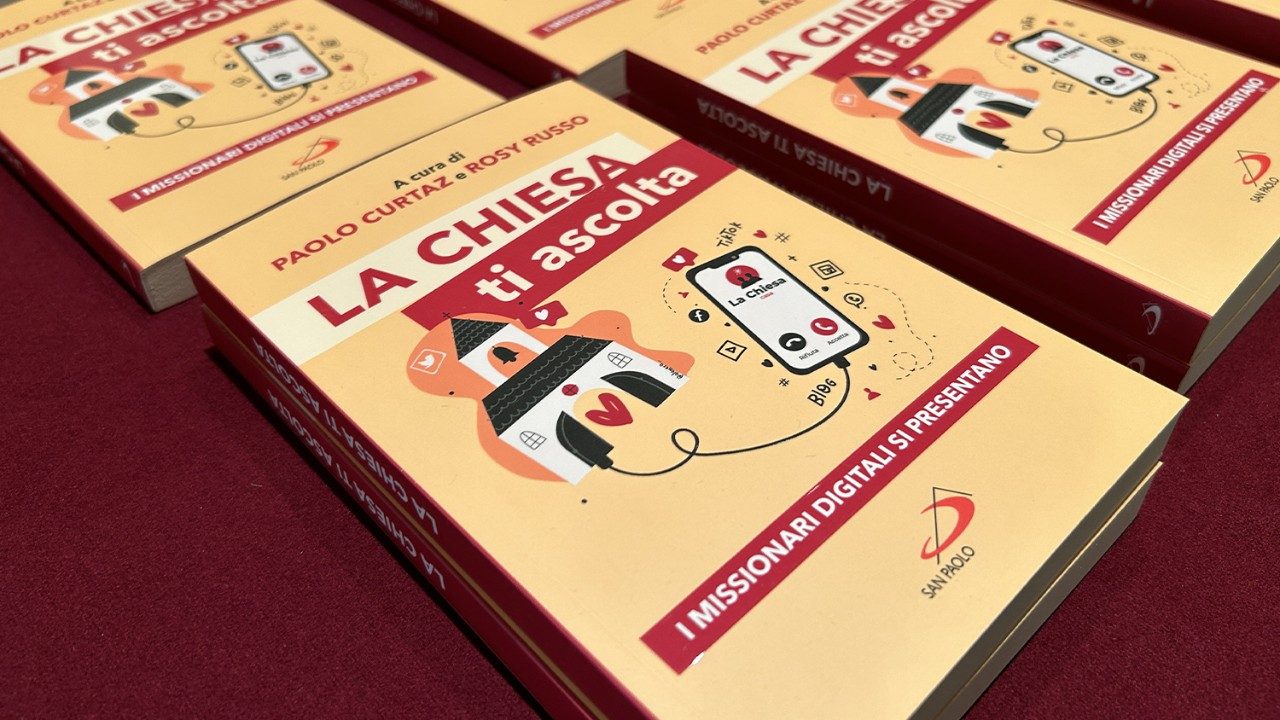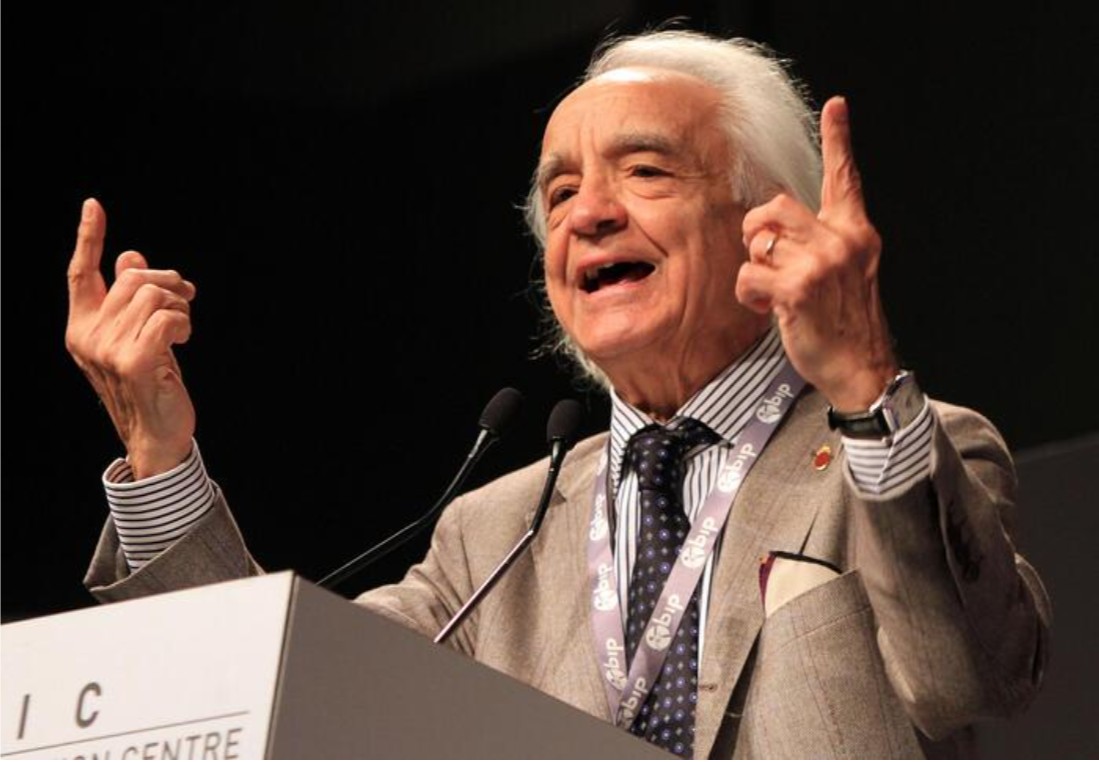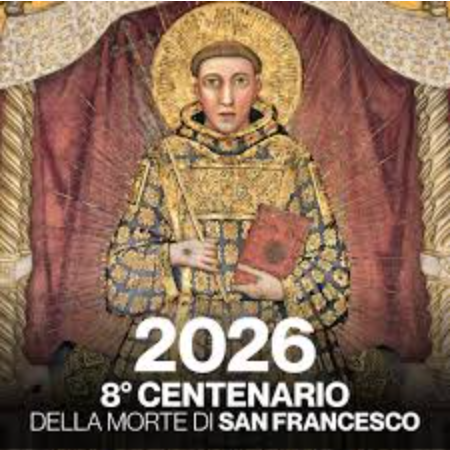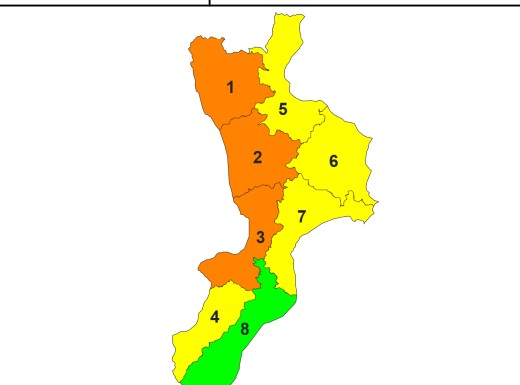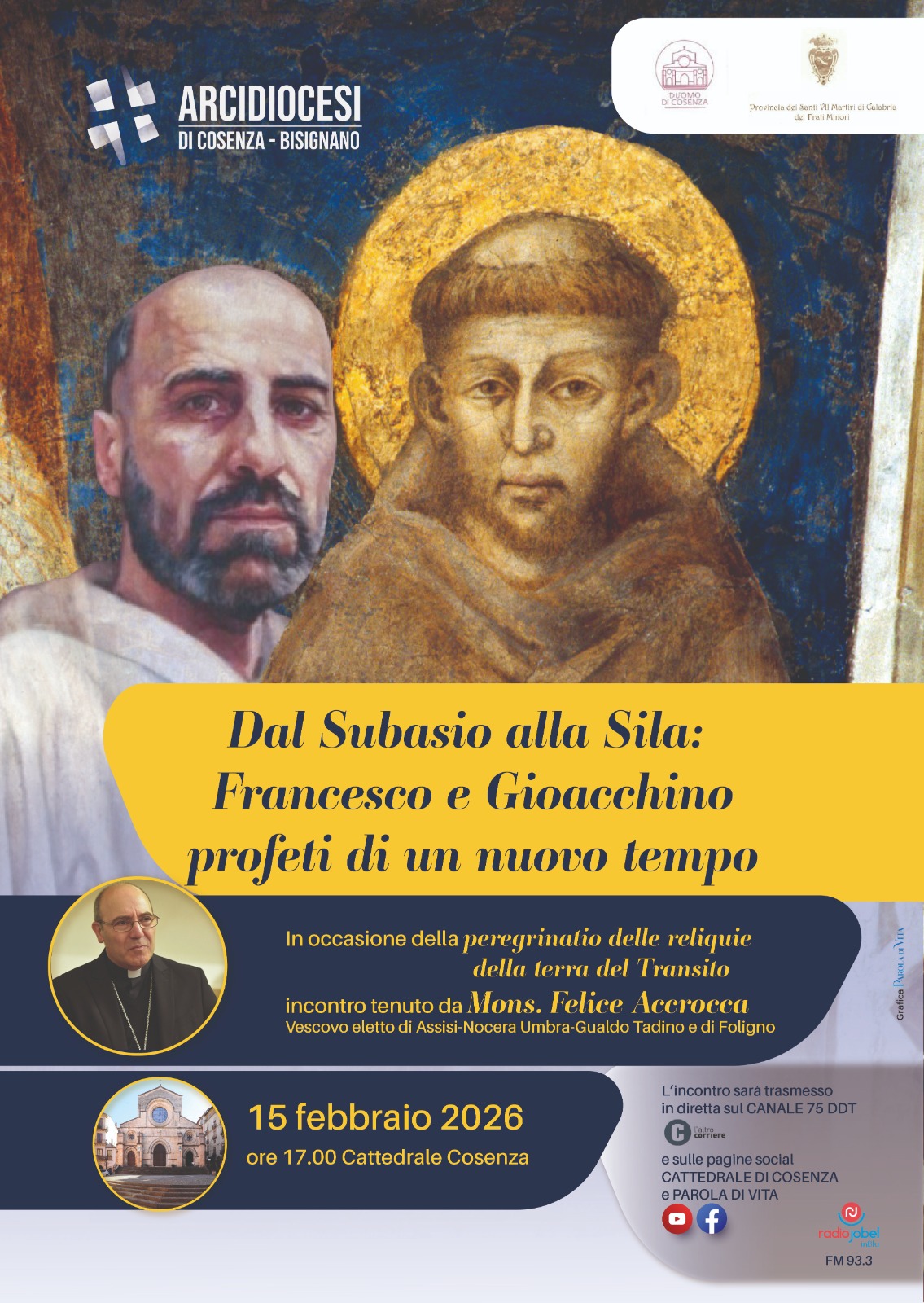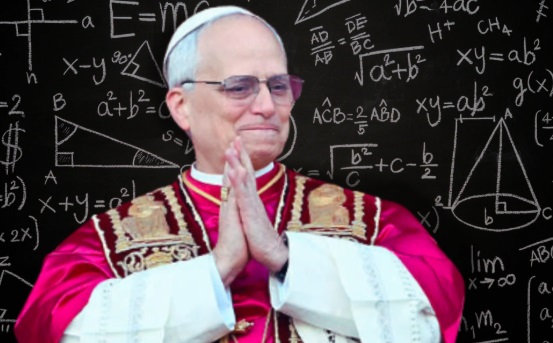Attualità
Quando la libertà resta sola

La scelta delle gemelle Kessler di ricorrere al suicidio assistito in Germania apre una domanda più ampia sul rapporto tra libertà e fragilità: cosa accade quando una decisione così definitiva è possibile anche senza una condizione clinica che la renda estrema? Un gesto che interroga la responsabilità collettiva, il senso dei limiti e la necessità di non lasciare nessuno solo davanti all’ultima soglia
Ci sono notizie che pur facendo rumore generano un silenzio particolare. Non perché manchino le parole, ma perché si avverte subito che le parole non devono correre, che c’è un confine che rischia di essere superato. La morte delle gemelle Kessler è degna di occupare il primo piano di ogni testata ma rischia di mettere in secondo piano la decisione che l’ha provocata: la richiesta di ricorrere al suicidio assistito, in un Paese che non pretende alcuna condizione clinica per accedere a questa possibilità, è una di quelle notizie che costringono a riflettere. Non per giudicare, quanto per capire che una simile scelta non riguarda soltanto chi la compie. Diventa una domanda rivolta a tutti noi, a ciò che intendiamo per libertà, per fragilità, per responsabilità.
Nessuno può giudicare né conoscere il peso dei giorni altrui. Nessuno può immaginare la trama di paure, stanchezze, affetti, che può spingere due sorelle anziane a decidere di uscire dalla vita allo stesso momento. La sofferenza non è mai misurabile dall’esterno. E proprio per questo colpisce che un gesto così definitivo possa essere realizzato senza che nessuno abbia avuto la possibilità di porre una soglia minima, un criterio condiviso, un luogo in cui il desiderio di morire venga almeno interrogato, accolto, accompagnato. Non per negarlo, ma per evitare che diventi un atto solitario avallato come opzione ordinaria.
Viviamo in una società attraversata da solitudini che raramente diventano visibili. C’è chi cerca di restare, pur tra fatiche che consumano; chi affronta malattie che logorano corpo e spirito; chi combatte ogni giorno con una forma di oscurità interiore che non trova nome. In questo contesto, rendere il suicidio assistito accessibile senza alcuna condizione rischia forse di trasmettere un messaggio ambiguo: che la morte possa apparire come una via praticabile non solo nel dolore insopportabile o nella malattia refrattaria, ma anche nella stanchezza, nella paura, nella sensazione che il futuro non abbia più nulla da offrire. E allora cosa ascolterà chi, proprio oggi, fatica a trovare un motivo per continuare?
La vera domanda non riguarda le Kessler. Riguarda ciò che accade quando la libertà viene lasciata sola, senza un contorno, senza un volto, senza quella presenza discreta di umanità che ricorda a ciascuno di noi il valore di ogni esistenza, anche quando chi la vive fatica a riconoscerlo. Una società che non indica neppure una soglia rischia di trasformare un gesto estremo in una possibilità tra le altre, cancellando il peso della vita proprio nel momento in cui quel peso dovrebbe essere condiviso. La libertà non può reggere da sola il peso dell’ultima decisione: non è fatta per l’isolamento, ma per essere sostenuta, accompagnata, illuminata.
E allora, forse, più che spiegare o giudicare, questa storia ci invita a vigilare. A non lasciare che il dolore diventi un fatto privato privo di interlocutori e far sì che chi ne è attraversato non si ritrovi da solo ad affrontarlo. A non trasformare la scelta di morire in un gesto ordinario. A custodire, nella discrezione dei giorni, quella trama di relazioni che impedisce alla fragilità di diventare resa. Non è una questione di legge, né di morale. È una questione di umanità: cioè di quella capacità che ci spinge a non abbandonare nessuno proprio quando la vita si fa più difficile da sostenere. È lì che si misura una comunità. È lì che si decide se la libertà è davvero una promessa o soltanto un’altra forma di solitudine.