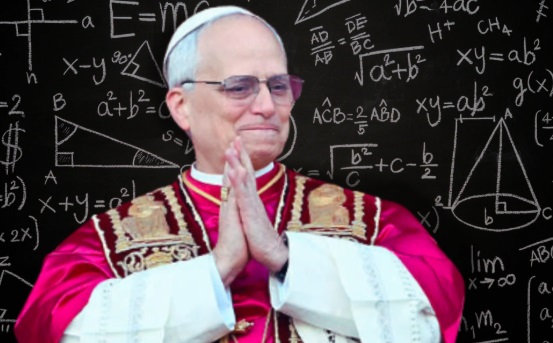Cultura
Storia e significato dei rosoni medievali nel libro di Armando Rossi

L’esperto cosentino ragiona sul senso delle finestre circolari, che possiedono principi di conoscenza percepibili solo da chi le sa osservare bene
Nel libro I Rosoni medievali: Significato, simboli, esoterismo e numerologia (Fontana editore) l’architetto cosentino Armando Rossi, docente di Disegno e Storia dell’Arte, ricostruisce la storia dei rosoni nella lunga età di mezzo. Queste finestre decorative circolari fungono da sigilli, posti sulle facciate delle chiese romaniche e gotiche. Il rosone nacque nel IV-V secolo, era chiamato “oculo” e lo si trovava sia in edifici religiosi che civili, rivestendo significati estetici e pratici. Fu con l’avvento del Romanico (X-XII secolo) e, successivamente, del Gotico (XII-XVI secolo) che raggiunse la sua massima espressione artistica, grazie anche ai lavori architettonici, alle sculture, ai mosaici e alle decorazioni dei Marmorari Romani Cosmati, operativi tra il XII e il XIII secolo. La rosetta assunse un’importanza notevole nelle chiese medioevali, specialmente in quelle romane, non solo per la sua funzione ornamentale ma anche per il fatto di essere icona di bellezza, immagine della perfezione della Creazione, espressa dalla forma circolare, e veicolo di trasmissione di storie bibliche. Questa finestra, infatti, unisce valori cristiani e laici e si rifà al mistero di Dio portatore di luce. La luminosità che promana dal Salvatore penetra nella chiesa dalle vetrate e, appunto, dai rosoni, stimolando i fedeli alla meditazione. Il rosone, secondo il prof. Rossi, nasconde in sé un significato esoterico non direttamente visibile, che travalica la mera comprensione superficiale, connesso all’anima di chi ha costruito l’edificio. Tale significato comunica il valore del bene architettonico, preserva il ricordo delle persone alle quali il bene stesso è stato destinato, e segnala la ritualità che c’era nel momento in cui è stato fabbricato. I rosoni sono come dei labirinti in continua evoluzione, costituiti da percorsi difficili che si snodano dalla periferia al centro. Sono emblemi di splendore e di stabilità, stimolano la riflessione cristiana ed esaltano l’armonia cosmica. Essendo portatori di unità e di perfezione, queste finestre circolari inducono il credente a rivedere e a ragionare sul suo rapporto con Dio. Esse rientrano tra gli esempi di esoterismo in ambito artistico, intendendo per esso quel meccanismo attraverso cui è possibile tramandare conoscenza implicita. Gli architetti inseriscono volutamente determinati elementi del sapere dentro un complesso monumentale, in una chiesa, in un quadro o in un rosone, non per occultarli ma per far sì che possano essere percepiti e letti, a distanza di tempo, da chi li sa percepire e leggere. Gli occhi allenati e competenti identificano un determinato “sigillum”, dato dal costruttore o da un gruppo di costruttori che hanno realizzato una qualsiasi opera. Questo simbolismo esoterico è usato da tutti i più grandi architetti della Storia, che hanno lavorato secondo dei principi precisi. Il romano Vitruvio ha stabilito i canoni dell’architettura in epoca romana, ritenendo che l’architetto sia colui in grado di “edificare in fortezza, bellezza e utilità”, Leon Battista Alberti, nel quattrocento, ha sancito il principio ideale dell’armonia proporzionale, in base ad una serie di regole di rapporti geometrico-matematici ispirati all’antichità, Michelangelo, che non si definiva architetto ma scultore, ha rotto con le convenzioni classiche optando per un uso drammatico della luce e delle ombre, e lavorando la materia in modo audace, innovativo e con forza espressiva, mentre Jacopo Barozzi da Vignola si è occupato della canonizzazione delle colonne e degli stili. Questi geni hanno recepito il processo esoterico non per nascondere, ma per immettere un principio di conoscenza nelle loro opere, che potesse essere riconosciuto da chi fruisce, restaura e custodisce le opere stesse.