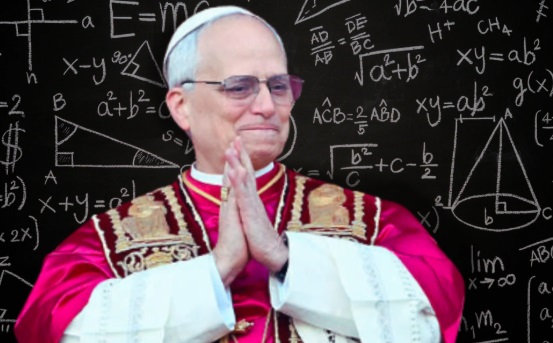Cultura
Calabria, terra di ricordi per De Angelis

Lo scrittore originario di Terranova di Sibari si ispirò a Corrado Alvaro e si interessò alla avanguardie novecentesche
La stagione estiva ci induce a riflettere sui contributi illuminanti offerti da insigni intellettuali nati in Calabria che, con la loro penna, ci hanno lasciato narrazioni veritiere della nostra regione. Vogliamo concentrarci sulla vita di Raoul Maria De Angelis (all’anagrafe Giovanni), scrittore, viaggiatore, giornalista e pittore, nato nel 1908 a Terranova di Sibari, in provincia di Cosenza, da una famiglia agiata di origini italo-albanesi. Dopo aver frequentato il ginnasio e il Liceo Classico Galluppi a Catanzaro, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza alla Sapienza a Roma. Decise di abbandonare gli studi e, a partire dal 1929, intraprese la carriera giornalistica e letteraria. Nella capitale venne a contatto con le correnti e le novità culturali del tempo: il realismo magico di Massimo Bontempelli, che dava priorità alle visioni oniriche, all’inconscio e ai miti, rompendo decisamente con il positivismo ottocentesco, il futurismo di Marinetti che disprezzava la tradizione ed esaltava la modernità, la nascita di riviste letterarie come il “900”, la rivoluzione delle avanguardie artistico-letterarie e l’esperienza del “Teatro degli Indipendenti” di Bragaglia, fucina di innovazione e di sperimentazione nell’ambito dello spettacolo. De Angelis si interessò subito al giornalismo, lavorando come inviato speciale per i principali quotidiani del periodo, tra cui “Il Giornale d’Italia”, “Il Messaggero”, “Il Resto del Carlino”, “La Gazzetta del Popolo”, “Il Tempo”, “Il Gazzettino”, “L’Ambrosiano”. Nel 1936 fu caporedattore del settimanale “L’Italia letteraria” di Bontempelli, su cui pubblicò a puntate, dal 26 gennaio al 19 aprile dello stesso anno, il suo primo romanzo dal titolo Inverno in palude, ambientato nella piana di Sibari. In questo libro rivivono i temi tanto cari a Corrado Alvaro che lo influenzò in maniera decisiva: il meridionalismo, la modernità, la condizione umana, la marginalità, la fatica fisica che si fa dignità, il dominio della natura sull’uomo, la stagnazione economica. La realtà, legata ai ricordi della nativa Calabria, viene trasfigurata in maniera favolistica e allegorica. Non manca un certo simbolismo predominante, a cui si accompagnano elementi che esprimono la condizione psicologica e sociale della Calabria del tempo. In una Sibari descritta come terra paludosa e affetta da malaria, emergono personaggi che non sanno imporsi sulla natura, che vivono in un luogo tutt’altro che accogliente, che sono lenti e parlano poco e che hanno difficoltà a lavorare la terra. La scrittura, allora, non può che avanzare in maniera lenta e paziente. Nel 1937 Raoul conobbe a Capri Erika Loeb, berlinese di famiglia ebraica, che diventò sua moglie. Vissero in Germania fino al 1938 quando, a causa del varo delle leggi razziali, furono costretti a fuggire in Brasile. Nel 1940 diede alle stampe il suo secondo romanzo, Oroverde, ambientato sempre nella piana di Sibari, nel quale intensifica gli elementi visionari e immaginari. Emerge l’immagine del grano (l’oro verde) che si contrappone alla pianura giallastra di color seta. Qui l’autore gioca sull’antitesi tra i braccianti, i pastori e gli uomini di collina, da una parte, e i bonificatori dall’altra. Questi ultimi vogliono deturpare e rovinare tutto ciò che potrebbe far fiorire la terra, la quale però non si lascia né intimidire né toccare ma punta alla rinascita. La descrizione della piana di Sibari risulta essere il tema principale sia in “Inverno in palude” che in “Oroverde”. Questa terra tenta una trasformazione, passando dallo status di pianura affetta da malaria allo status di territorio in cui si sperimenta il lavoro agricolo. De Angelis, tuttavia, mostra il fallimento di questa trasformazione, perché la palude seguita ad espandersi, l’oro verde intossica e il paese muore. Lo scrittore non racconta solo oggettivamente la Calabria, ma presenta l’immagine di una regione che ha un certo impatto sui corpi e sulle menti, condiziona la lingua usata e plasma la vita. La parola si fa più grave e si presta a narrare un’apocalisse senza ironia, dando voce alle cose anche quando sembra duro citarle, e costruendo un universo magnetico e ossessivo. Tra le altre opere ricordiamo Nel paese del caucciù: viaggio nel Brasile (1942), Foresta vergine (1945) e La peste a Urana (1943), la sua opera più nota. In quest’ultimo romanzo d’avventura, Raoul parla della vana ricerca dell’identità da parte dell’adolescente Giovanni, che si muove dentro due città fantastiche, Urana e Lupigna, sconvolte dalla peste. Il protagonista ha un’indole libertina ed è attratto dall’eros e dalle donne, il che lo induce a non rispettare le regole e ad essere un eversore. Colpa di tutto ciò è anche il morbo, che travolge e disintegra tutto e tutti. A ciò si aggiunge la malattia del pettegolezzo che, insieme alla lussuria, contribuisce al disfacimento personale, alla solitudine del sopravvissuto, alla crisi delle strutture comunitarie e alla fine dei legami sociali. In quest’opera, così come nelle prime due già accennate, De Angelis esplora la condizione dell’uomo, che non riesce a comprendere l’ordine nel quale è inserito, e approfondisce il rapporto tra natura, storia e marginalità della coscienza. La scrittura si adegua a quest’ordine diventando densa e ripetitiva, mentre il tempo si ferma. L’opera sembra collocarsi fuori dai generi dell’epoca, pur rimanendo connessa alla realtà. Come pittore, dagli anni sessanta in poi curò mostre personali a Roma e all’estero, tra cui quelle a Bruxelles, Parigi e Lugano. Morì a Roma nel 1991 a 83 anni.