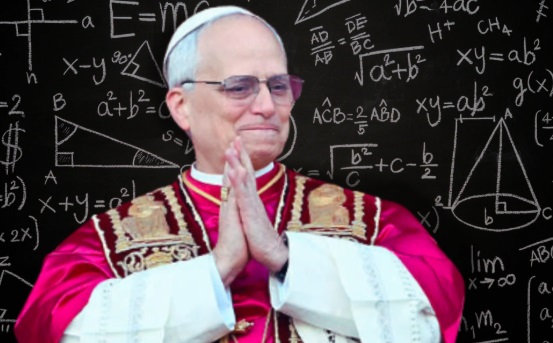Cultura
Beato Rosmini padre della patria

Quest’anno ricorrono i 170 anni dalla morte del famoso intellettuale e presbitero trentino
Se c’è un presbitero che in vita è stato profondamente legato alla Chiesa cattolica, al punto da difenderla e proteggerla da qualsiasi attacco esterno, questi è il Beato Antonio Rosmini. Nato a Rovereto nel 1797, può essere definito un vero e proprio gigante della cultura ottocentesca italiana, un intellettuale di alta levatura morale e dai tanti interessi, che spaziavano dalla spiritualità alla filosofia, dalla teologia alla politica. Crebbe in un momento in cui il Trentino stava vivendo una delle ore più cupe della sua storia. Il principato vescovile – un antico stato ecclesiastico nato prima dell’anno 1000, e parte del Sacro Romano Impero – stava per essere cancellato a seguito delle guerre tra l’Austria e Napoleone. Dopo la Restaurazione, il territorio trentino sarebbe entrato a far parte del Tirolo, all’interno dell’Impero asburgico. Una sorte che sarebbe stata molto gradita dalla stragrande maggioranza della popolazione. Una piccola minoranza, tuttavia, per lo più borghese o appartenente alla piccola nobiltà, guardava con interesse all’idea di uno stato unitario italiano. Ed è proprio a questa esigua minoranza che apparteneva la famiglia Rosmini. Il giovane Antonio era molto intelligente, studioso e dotato di una forte religiosità cristiana. Dopo aver incontrato il vescovo di Chioggia, Giuseppe Manfrin Provedi, a Rovereto, Antonio avvertì la vocazione al sacerdozio e venne ordinato nella stessa cittadina veneta all’età di 24 anni nel 1821, anno in cui scoppiarono, nel mese di aprile, i moti liberali e in cui morì Napoleone (5 maggio). Le sue divergenze con le autorità austriache e le sue idee religiose, filosofiche e politiche, accolte con scarso entusiasmo dal suo vescovo, lo costrinsero a trasferirsi nel 1826 a Milano, cuore della cultura italiana. Il sacerdote trentino, pur essendo credente, non fu pienamente in linea con il pensiero ufficiale della Chiesa del tempo. Il suo essere cattolico liberale non era condiviso dalle frange ecclesiastiche tradizionaliste, il che lo costrinse a ritirarsi sul Lago Maggiore. Insieme a Vincenzo Gioberti e a Manzoni, aderì a quel filone del pensiero interessato ad approfondire il ruolo della cultura cristiana dentro il dibattito risorgimentale, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra stato, nazione e popolo. Il sentimento patriottico che Rosmini condivideva con Manzoni fu rilevante ma gli valse l’antipatia dei canonici più vicini al Papa, specialmente dopo la presa di Porta Pia. Portò avanti tesi filosofiche opposte all’illuminismo e al sensismo, criticò il socialismo e il comunismo, postulando l’idea di un limitato intervento da parte dello stato, e si schierò a favore dei diritti naturali, della proprietà privata e del liberismo economico. Volendo concepire una funzione ordinatrice dell’esperienza, il presbitero si avvicinò alle idee di Kant ma non accettò il concetto di innatismo che, a suo avviso, era legato ad una serie di categorie che non garantivano la cognizione del reale, prevedendo invece il ricorso a categorie soggettive per giungere alla piena conoscenza. Fondamentali per lui furono anche le lezioni di Sant’Agostino e di San Tommaso. In politica Rosmini appoggiò uno stato costituzionale, con una particolare preferenza per la monarchia costituzionale, e spinse in direzione di una separazione tra Stato e Chiesa. Fu tra i principali protagonisti del dibattito teologico e filosofico dell’Ottocento, incidendo sui grandi pensatori del Risorgimento italiano (Manzoni, Gioberti, Mamiani, Tommaseo). Nel 1828 lasciò definitivamente i confini asburgici, scegliendo di vivere a Domodossola dove fondò, sul Sacro Monte Calvario, la Congregazione religiosa dell’Istituto della Carità, chiamato successivamente dei “Rosminiani”. Le Costituzioni di quest’ente, riconosciute da papa Gregorio XVI nel 1839, si basavano sul proposito di combattere i vizi dell’anima e di fare sempre la carità verso il prossimo. In Piemonte, a Borgomanero, Rosmini si dedicò all’insegnamento e fu anche guida spirituale in un collegio che, in seguito, prese il suo nome e che fu retto dalla Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiane, fondata nel 1832. Morì il 1° luglio 1855 nella sua casa a Stresa, a causa di una malattia al fegato provocata da un episodio di avvelenamento. Amici e collaboratori si precipitarono al suo capezzale, tra cui don Paolo Orsi, vecchio amico di famiglia, il suo amico Pier Alessandro Paravia, il linguista Tommaseo, che addirittura si mise a recitare il Rosario, e Alessandro Manzoni. Quest’ultimo lo conobbe nel 1826 a Milano e, a partire dal 1837, ebbe con lui stretti contatti a Stresa, dove si era trasferito con la seconda moglie, Teresa Borri. La stima reciproca tra i due, la complicità intellettuale, la condivisione delle idee politiche e religiose e l’incessante scambio epistolare portarono il padre dei Promessi Sposi a definire Rosmini “una delle sei o sette intelligenze che più onorano l’umanità”. Manzoni stette vicino al suo più caro amico fino alla morte, quando rilasciò il suo testamento spirituale: “Adorare, tacere, gioire”. Il presbitero fu autore di grandi opere filosofiche e religiose, tra cui le Massime di perfezione cristiana, il suo principale capolavoro, in cui sostiene che la perfezione cristiana esiste e dipende dalla pratica di alcune massime. Pubblicò anche Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa e Della Costituzione secondo la giustizia sociale che non furono ben accolte dalla Chiesa e vennero scritte nell’Indice dei libri proibiti. Nella prima, in particolare, espose i rischi (piaghe) che la Chiesa del tempo correva e che minacciavano la sua unità e la sua libertà. Fu chiesta una revisione di tutte le sue opere, fino a quando Pio IX lo assolse da ogni accusa nel 1854. Nonostante le critiche Rosmini restò un fedele servitore della Chiesa a cui non voltò mai le spalle. Quando scoppio la rivolta anticlericale guidata da Mazzini a Roma nel febbraio 1849, che terminò con l’istituzione della Repubblica Romana e l’esilio a Gaeta di Pio IX, il religioso non abbandonò il Pontefice e l’accompagnò nella cittadina latina. Papa Mastai-Ferretti rammentò questo nobile gesto del sacerdote trentino e volle in seguito che facesse parte della commissione, per l’approvazione del dogma dell’Immacolata Concezione. Pio IX parlò di Rosmini dicendo: “Non solo è un buon cattolico, ma santo: Iddio si serve dei santi per far trionfare la verità”. Il Concilio Vaticano II ne riscoprì il nome e la sua opera iniziò a diffondersi massimamente. La sua completa riabilitazione avvenne sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, che lo citò come una delle menti più coraggiose nell’Enciclica “Fides et Ratio”. Benedetto XVI lo beatificò il 18 novembre 2007 a Novara. Rosmini è stato un anticipatore del dialogo tra scienza e spiritualità, indicando nella ragione il mezzo necessario per la realizzazione del sé credente.