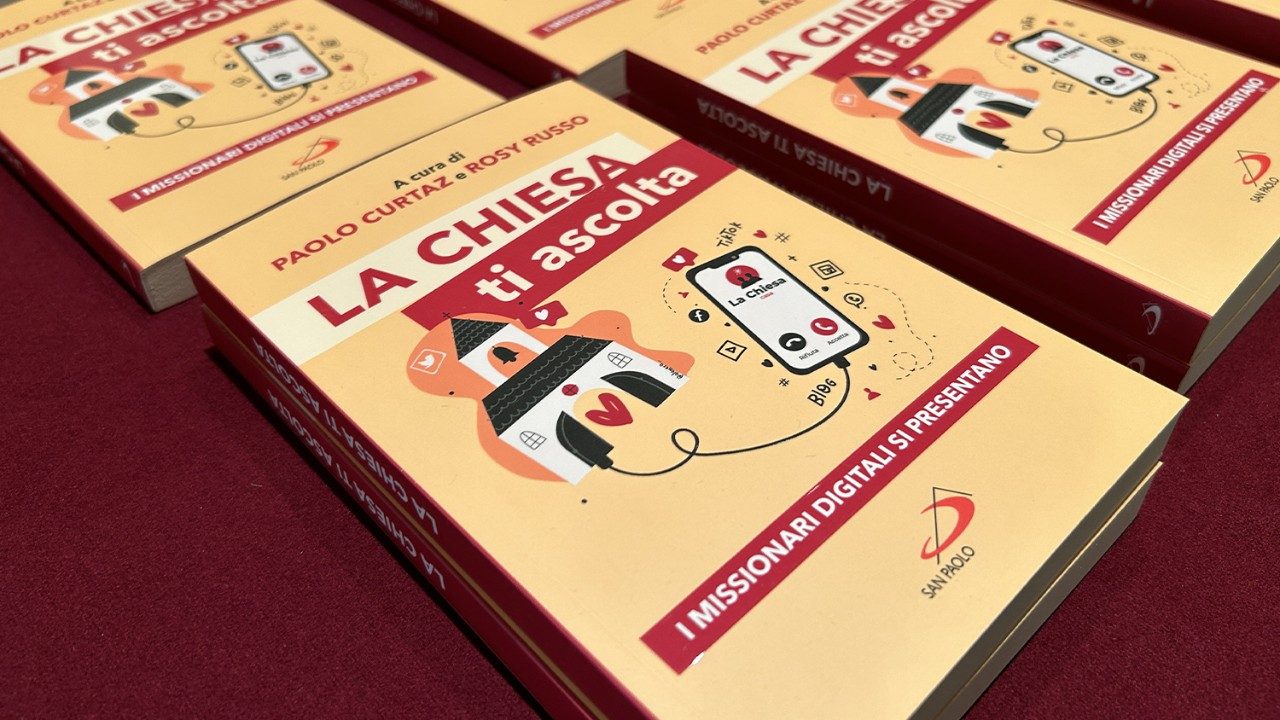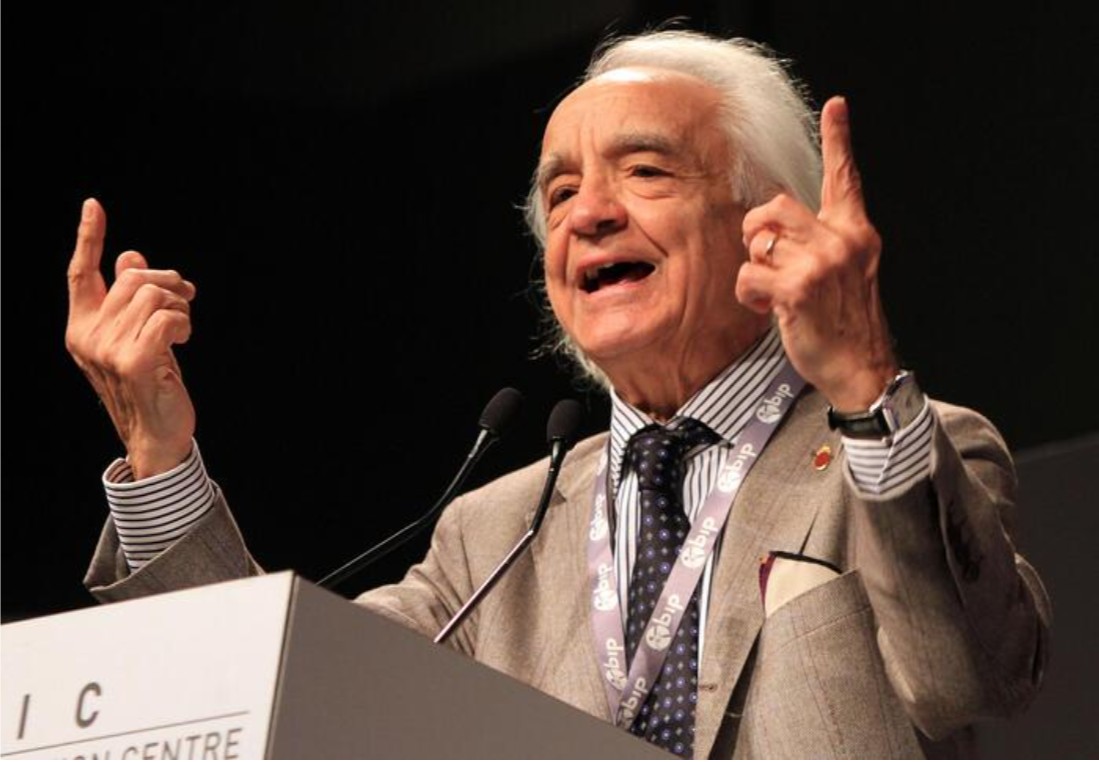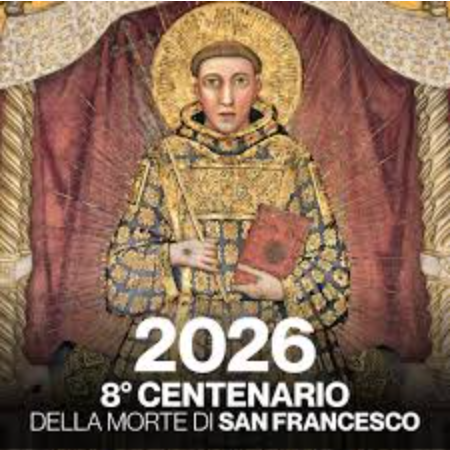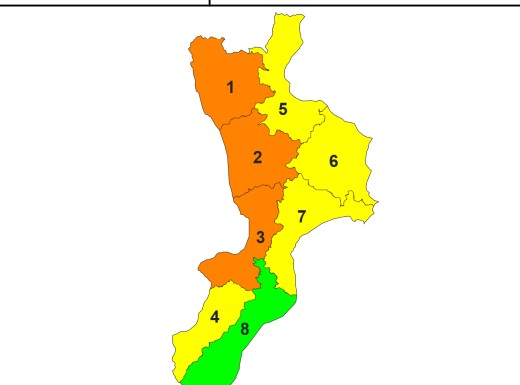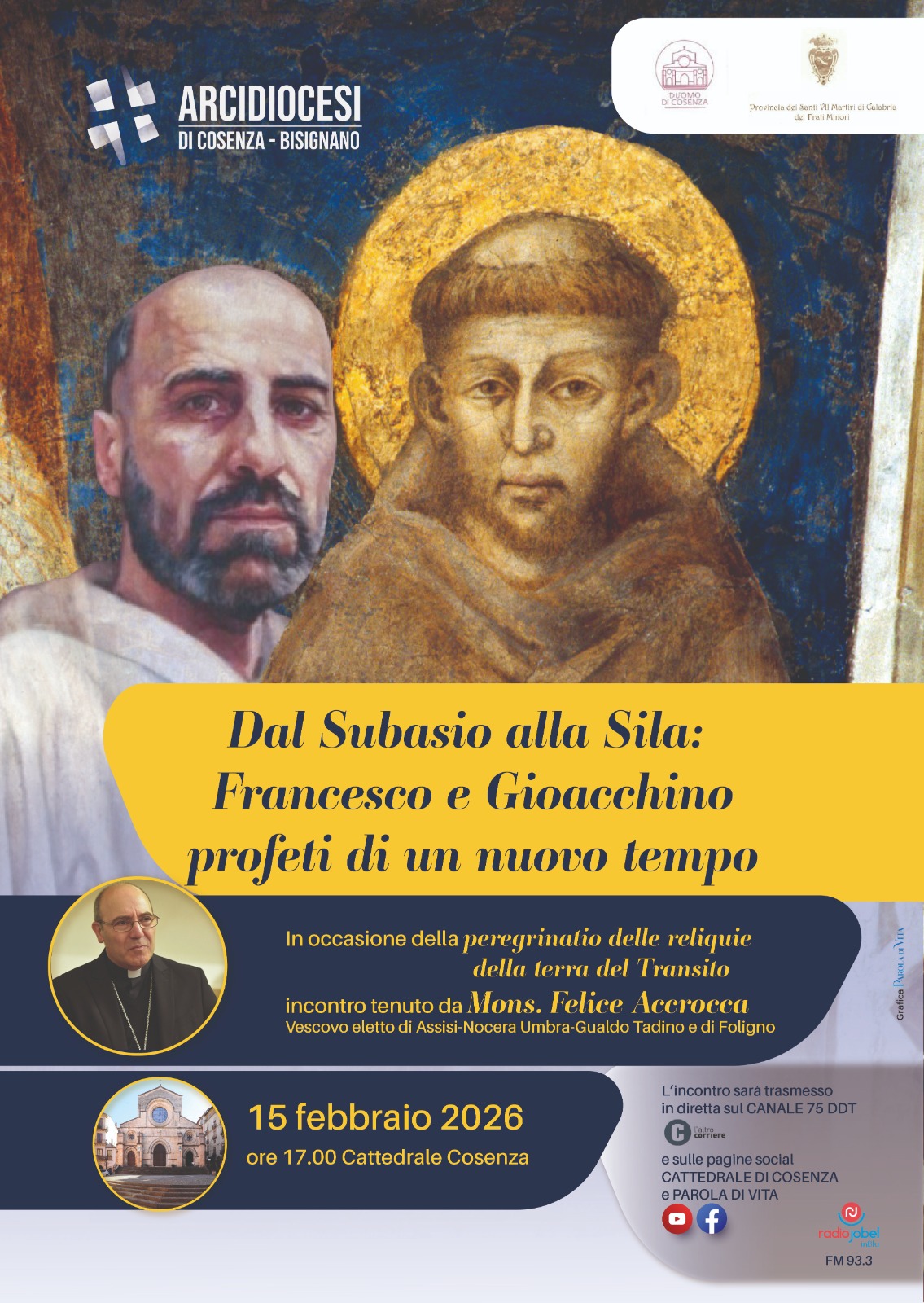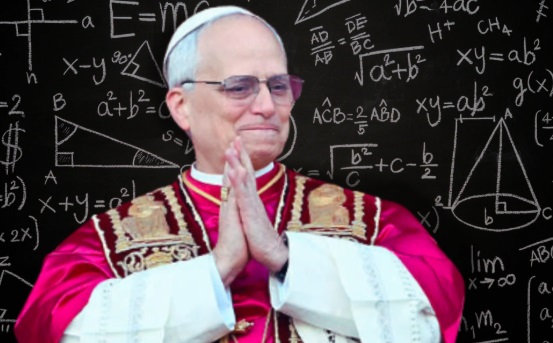Cultura
Dall’epistola XI di Dante un richiamo all’unità per l’elezione del nuovo papa

Il Sommo Poeta si rivolge agli alti porporati, esortandoli a trovare fra di loro un amorevole accordo, per la scelta del nuovo vicario di Cristo
L’elezione del nuovo pontefice richiede, oltre alle necessarie misure di sicurezza e di massima segretezza, una certa disposizione all’unità da parte dei cardinali che, sotto la spinta dello spirito santo, sono tenuti ad eleggere il successore di Pietro guardando al bene della Chiesa. Ciò è possibile superando le divergenze e cercando un punto di incontro tra prospettive eterogenee. Le diatribe interne al conclave non sono mai mancate nel corso dei secoli, e c’è stato anche chi ha sfoderato le sue doti intellettuali per convincere i porporati ad accordarsi sul nome del nuovo papa.
Facciamo un salto nel passato, in particolare a quel 1314 quando, dopo la morte di Clemente V (1264-1314), la Sede Apostolica restò vacante. Era già iniziato il periodo della cattività avignonese (1309-1377), contraddistinto dall’attaccamento alla ricchezza e dalla mondanizzazione dell’istituto ecclesiastico. Erano anni particolarmente intensi anche sotto il profilo culturale, grazie alla produzione letteraria di Dante, Petrarca e Boccaccio. Il Sommo Poeta, nello specifico, aveva a cuore il destino della Chiesa. Era un grande credente nonché testimone della fede cristiana. Il suo legame al cattolicesimo è evidenziato in diversi canti della Divina Commedia, in particolare nel canto XXIV del Paradiso dedicato proprio alla fede. Qui Alighieri, sotto la volta del cielo stellato, è sottoposto ad un esame teologico da tre apostoli: Pietro, Giacomo e Giovanni. Alla domanda “fede che è” il poeta risponde “fede è sustanza di cose sperate / e argomento delle non parventi” (vv. 64-65). Si può notare il riferimento puntuale alla versione latina della Vulgata che Dante conosceva sicuramente. Seguono altre domande fatte al Sommo Poeta, attraverso le quali mostra il suo credo. Professa in maniera quasi liturgica “Io credo in Dio…” (130) su invito di Pietro, presentandosi come un fervente cattolico. Con lui si può comprendere che “la fede è la più alta passione dell’uomo”, riportando le parole di Kierkegaard. Dante era completamente immerso nell’universo della cristianità medievale, e aveva sempre lo sguardo fisso a quel cielo dove brilla la luce della trascendenza.
Un episodio specifico lo legò al conclave che fu aperto nel 1314. Nella primavera di quell’anno, i cardinali si riunirono nella città francese di Carpentras, per eleggere il nuovo pontefice dopo la scomparsa di Clemente V. Il poeta fiorentino scrisse l’epistola XI, indirizzandola ai porporati italiani che si stavano per chiudere in clausura. Li esortò a scegliere un valido nome, che potesse riportare la sede papale a Roma, sottolineando l’importanza di ristabilire l’autorità spirituale nella città eterna. Questa missiva svela tutte le preoccupazioni dell’intellettuale in merito alla corruzione e alla decadenza morale della Chiesa, nel periodo della cattività avignonese. L’epistola XI si apre con una citazione tratta dal libro delle Lamentazioni (1,1) del profeta Geremia: “Quomodo sola sedet civitas plena populo, facta est quasi vidua domina gentium!” (“Come sta sola la città piena di popolo, la signora delle nazioni è diventata come una vedova!”). Il riferimento alla città santa servì per denunciare la drammatica situazione in cui versava la Santa Sede nel trecento, situazione che rischiava di aggravarsi sempre di più per la corruzione nelle sfere ecclesiastiche di quel tempo. Dante voleva che i cardinali ritrovassero l’unità e la pace fra di loro e guardassero al bene della Chiesa universale. Scrive sempre nella stessa missiva: “pro sponsa Christi, pro sede sponse, que Roma est, pro Ytalia nostra et, ut plenius dicam, pro tota civitate peregrinante in terris” (“per la sposa di Cristo, per la sede della sposa che è Roma, per la nostra Italia e, per dirlo in modo più ampio, per la città intera pellegrina sulla terra”). Alcuni studiosi hanno avanzato l’ipotesi che la lettera sia rivolta, in primo luogo, al cardinale Napoleone Orsini e alla disputa con il cugino Matteo Rosso Orsini, che si concluse con l’elezione al Soglio pontificio di Clemente V e, quindi, con l’inizio della cattività avignonese agli inizi del trecento. La speranza del poeta, in occasione del conclave del 1314, era che non venisse commesso lo stesso errore e che la sede apostolica tornasse nuovamente a Roma, la città del martirio di Pietro e della morte di Paolo. L’epistola XI ci è pervenuta per mezzo dell’unico testimone, il manoscritto Pluteo 29.8 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, definito lo Zibaldone Laurenziano di Giovanni Boccaccio, grande studioso e divulgatore dell’opera dantesca. La lettera, rivolta dal Sommo Poeta ai cardinali, è di estrema attualità. Il fiorentino ha avuto il coraggio di parlare e di consigliare le toghe rosse, in un periodo storico pieno di controversie. Il suo messaggio vive ancora ed è condivisibile in queste ore, che ci distaccano dalla nomina del nuovo pontefice: “ritrovare il senso dell’unità e sceglie un nome che sappia guardare al destino della Chiesa”.